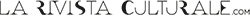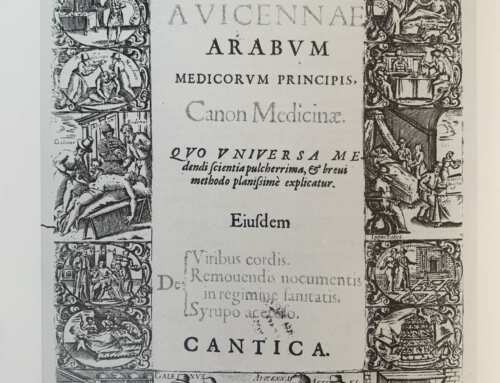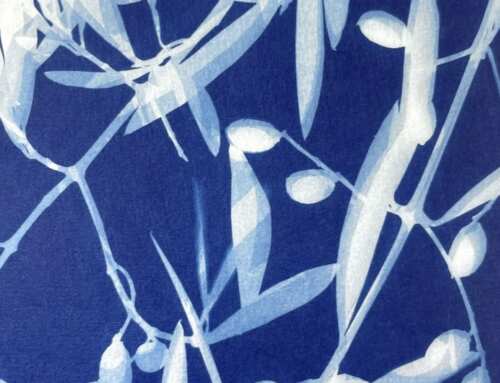Pubblicato il 16 Maggio 2022
Serendipità, indizi trovati non per caso
di Telmo Pievani

Benché anche Ginzburg nel suo saggio citasse la serendipità, le connessioni tra le capacità abduttive e il trovare ciò che non si va cercando restano assai deboli. Lo dimostra il fatto che, sulla scia di Zadig, tutti i campioni del sapere indiziario siano pressoché infallibili, altro che scienza dell’inatteso. Devono risolvere un mistero, applicano il metodo indiziario e colgono nel segno. Nei Delitti della Rue Morgue, capolavoro poliziesco di Edgar Allan Poe, estremizzazione letteraria dell’abduzione che ispirò Arthur Conan Doyle, il detective Auguste Dupin analizza ogni dettaglio, procede per esclusione e riesce persino a leggere nella mente del suo amico, ricostruendo i passaggi del suo ragionamento.
“L’osservazione è una specie di necessità”, sentenzia. Certo, bisogna pensare a ciò che nessuno ha pensato, come lo scienziato dinanzi a un’anomalia, non ritrarsi nemmeno di fronte alle ipotesi più strane (persino che il colpevole sia un orango), ma alla fine comunque, magari con l’aiuto della gloriosa teoria delle probabilità, “l’esperienza rivela sempre la sua vera logica”. Gli avvenimenti collaterali e accidentali sono importanti, ma Dupin li domina rendendoli “oggetto di calcolo assoluto”, riconducendo l’imprevisto a formula matematica. Il risultato finale dunque è negazione della serendipità.
Sherlock Holmes non è da meno. Il suo inventore, Arthur Conan Doyle, era medico, allievo e segretario di un esperto di semeiotica medica, Joseph Bell, chirurgo a Edimburgo, amante dell’induzione, delle connessioni tra indizi, mago delle diagnosi in corsia, che poi il giovane Arthur Conan Doyle doveva redigere per iscritto. Conan Doyle scrisse i primi bozzetti del suo personaggio mentre aspettava i pazienti nel suo ambulatorio specialistico, tra un viaggio in nave e l’altro come medico di bordo. Per un anno studiò anche la tubercolosi in Germania con Robert Koch, ma senza rimanerne molto impressionato. Il detective Holmes è dunque figlio del sapere indiziario in medicina. Bell era rinomato per il suo straordinario spirito di osservazione: non solo coglieva al volo la malattia, ma spesso anche la professione e il ceto del paziente, senza chiedergli nulla. Sherlock Holmes è la sua incarnazione letteraria, solo leggermente drammatizzata.
Da Bell dunque e dall’esempio del detective Dupin di Poe, Conan Doyle trasse nel 1886 il modello di un poliziotto scientifico con grandi capacità di indagine. Doveva applicare un rigoroso e realistico metodo indiziario, non affidandosi a coincidenze fortunate, ma a orme nel fango, ceneri di sigaretta, calli sulle mani, usure e piccoli dettagli impercettibili ai più. Il protagonista deve meritarsi il successo con la fatica e il ragionamento, non scoprire il colpevole grazie a circostanze fortuite. Nella finzione letteraria, Holmes è addirittura autore di cataloghi sistematici e quasi paranoici di indizi quali ceneri di sigaretta e calli sulle mani.
Qui c’è ben poca serendipità. I colpi di fortuna non esistono quasi mai nella vita reale, scrisse Conan Doyle in una lettera del 1900 in cui raccontava la nascita del suo personaggio. Ecco perché gli venne in mente di ispirarsi al suo vecchio professore di Edimburgo, alla sua logica implacabile che dagli effetti risaliva alle cause e così diagnosticava a colpo d’occhio le malattie. Il maestro medico peraltro apprezzò la dedica e lo disse a Conan Doyle nel 1892. Da allora cominciò persino a mandargli suggerimenti su criminali e delitti. Holmes dunque è ancor più scienziato di Dupin, razionale e sistematico. La scienza prende il posto del caso e i delitti quello delle malattie.
A ben vedere, Sherlock Holmes, quasi disumano, senza cuore ma dotato di una magnifica intelligenza logica, porta l’abduzione a conseguenze così estreme da negarla. Watson fa da contraltare alle sue presunzioni di infallibilità, ma senza grossi risultati. E infatti la scienza di Holmes viene presentata non come abduzione ma come deduzione logica: da premesse generali a conseguenze sottese e inevitabili. Nel primo capitolo del Segno dei quattro, “La scienza della deduzione”, Sherlock Holmes definisce l’investigazione “una scienza esatta”, priva di emozioni e romanticismi fuorvianti, un ragionamento analitico che dagli effetti risale alle cause e risolve l’enigma.
Le qualità personali non devono fuorviare questo esercizio galileiano. Il cliente, dice Holmes scandalizzando Watson, è solo un numero, un fattore in un’equazione. È un’arte, l’investigazione, che richiede intuito, certo, ma anche tante nozioni, capacità di osservazione, di mettersi nei panni del criminale, di minuziosa classificazione. Come quella di Zadig, anche la scienza di Holmes si occupa di minuzie, per esempio catalogando le 140 varietà di tabacco che lasciano altrettante differenze tra le rispettive ceneri (poi però risolve il caso alla vecchia maniera, ricorrendo al fiuto di un buon cane poliziotto).
Tale scienza non è affatto serendipitosa ma al contrario esatta, secondo l’imbattibile Sherlock Holmes, perché “una volta che abbiamo eliminato le altre variabili, quello che resta è la verità”. O detto in modo più filosofico poco oltre: “eliminato l’impossibile, ciò che rimane, per quanto improbabile, deve essere per forza la verità”. Si tratta nientemeno che del tipico procedimento sperimentale per cui si analizzano, si comparano e si scartano le diverse variabili e ipotesi in gioco, al fine di corroborare una teoria (scientifica e investigativa) scartando le false piste.
Il detective di Conan Doyle è consapevole che questa scienza funziona fino a un certo punto, cioè solo quando sei sicuro di, e hai gli strumenti per, valutare davvero tutte le variabili potenziali. Spesso restano sul tavolo diverse congetture, altrettanto probabili o improbabili, perché la natura umana e non umana sa essere contorta. “Che strano enigma, l’uomo!”, scrive Conan Doyle. Quando agisce da solo è “un rompicapo insolubile”. Il resto allora è calcolo delle probabilità e fortuna, ammette Sherlock Holmes, come del resto Guglielmo da Baskerville. Quindi non è esattamente una scienza esatta, ma l’ambizione è quella. Indimenticabile dentro il suo impermeabile sgualcito, è decisamente più umano il tenente Colombo di Peter Falk, attentissimo osservatore apparentemente sbadato: dalla prima scena sappiamo chi è il colpevole, ma si resta incollati per assistere alla sua prodezza investigativa.
Telmo Pievani
Quest’estratto è tratto del libro Serendipità. L’inatteso nella scienza, di Telmo Pievani, Raffaello Cortina editore
Immagine: Nedko Solakov – Amadoodles, 2007, black ink on wall, dimensions variable, Photo Ela Bialkowska, courtesy Galleria Continua-Installazione di Nedko Solakov al Castello di Ama in Chianti
Telmo Pievani è professore ordinario di Filosofia della Scienza all’Università di Padova.