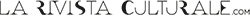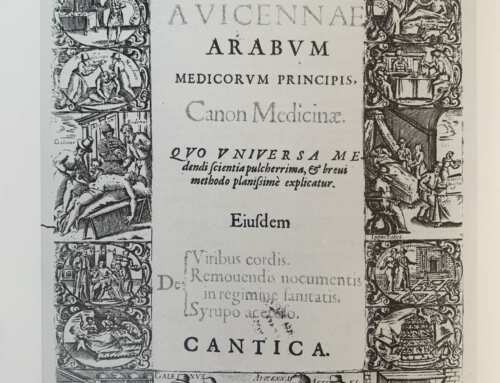Pubblicato il 18 Giugno 2022
Mangiarti. Quattro modi rivoltanti in cui la metafora cannibalica ha parlato d’amore e d’odio
di Valeria Russo

Usare il cannibalismo come metafora è piaciuto molto alla letteratura in questa parte di mondo, malgrado i tabù. Da culto eucaristico a pratica magica, in Occidente l’immagine cannibalica ha significato spesso qualcos’altro, non solo l’antropofagia.
Uno dei valori simbolici che la letteratura e il cinema hanno attribuito al cannibalismo è la sopraffazione dell’altro che si esplica, in forma di metafora, attraverso la sua riduzione a cibo. Se di metafora si tratta, il cannibalismo non può avere per premessa la fame e per scopo la sazietà, perlomeno non quella fisica presa in senso letterale. La metamorfosi dell’altro in materia commestibile, infatti, traduce una volontà di annichilimento, rappresenta lo sfogo di un bisogno di prevaricazione sessuale e sociale.
La metafora cannibalica che associa l’amore all’odio nutre il leitmotiv medievale del cuore mangiato. Ritroviamo questa immagine in una delle brevi biografie dei trovatori, quelle che si chiamano vidas e che, frutto di un’invenzione essenzialmente metaletteraria, introducono le raccolte dei componimenti poetici medievali in lingua occitana.
Tra le altre, la vida di Guilhem de Cabestanh racconta il funesto epilogo della sua relazione amorosa extra-coniugale. Il poeta ama una donna sposata e lei si concede, oltraggiando il proprio marito. Nell’ottica di questa tradizione letteraria, il problema non è tanto che la dama sia una traditrice, quanto che il coniuge scopra il tradimento. Scoppia dunque lo scandalo e viene architettata la vendetta dal marito ferito, che non si accontenta di uccidere l’amante di sua moglie, ma gli strappa via il cuore. Che se ne fa? Lo offre in pasto proprio a lei che, inconsapevole, se ne ciba. Segue il suicidio della donna, tanto ripugnata quanto disperata. Una vicenda semplicemente tragica, se non fosse che il castigo escogitato dal marito geloso consente ai due amanti di legarsi per l’eternità: lui la ama e perde la sua vita per lei, ma lei rimarrà l’unica detentrice del suo cuore (simbolicamente, quindi anche post mortem, o post-digestione), alimentando così il processo di trasformazione dell’amore in odio, di nuovo poi in amore.
La letteratura e il cinema post-bellici si sono appropriati dell’immagine cannibalica e della sua potenza involuta per mostrare e studiare la propria mostruosità e i processi di oppressione. In chiave sociale, questo si traduce in una scena, disturbante e oscena, di un dolorosissimo capolavoro di Curzio Malaparte.
Nel romanzo La Pelle (1949), leggiamo di Napoli durante l’occupazione alleata, divorata da chi l’ha salvata, da chi è capace solo di ammirarne l’incanto senza capirne la desolazione. Gli Alleati si nutrono e consumano le straordinarietà di una città che si offre in pasto ai suoi nuovi paladini, pronta a farlo anche per i prossimi, come per chiunque altro. Malaparte metaforizza questo processo attraverso immagini straordinarie.
Ricordiamo, una tra tutte, la cena tra dignitari in cui viene servito il corpo cotto di un pesce pescato non dal mare (vita), ma dall’Acquario di Napoli (vetrina). Il pesce è infatti bello in maniera eccezionale, tanto da assomigliare a una bambina nell’età dello sviluppo, il cui corpo è parzialmente spappolato dalla cottura ma che presenta in volto un’espressione di gioia. È come se, lusingata dal trovarsi al tavolo dei grandi, la sirena napoletana godesse del lusso dei soffitti affrescati e delle argenterie. Costituirà dunque la principale vivanda di quel granguignolesco banchetto diplomatico:
Era la prima volta che vedevo una bambina cotta, una bambina bollita: e tacevo, stretto da un timor sacro. Tutti, intorno alla tavola, erano pallidi d’orrore. Il Generale Cork alzò gli occhi in viso ai commensali, e con voce tremante esclamò: “Ma non è un pesce! È una bambina!”.“No” dissi “è un pesce.” “Siete sicuro che sia un pesce, un vero pesce?” disse il Generale Cork passandosi la mano sulla fronte madida di freddo sudore.“E un pesce” dissi “è la famosa Sirena dell’Acquario.”
Curzio Malaparte, La Pelle, Adelphi, 2010 (5a edizione), p. 223.
A Napoli sono i poveri ad essere divorati dai potenti che, in virtù di un ruolo salvifico, divorano tutto ciò che trovano, anche le persone, mentre i poveri, in segno di gratitudine nei confronti del liberatore, si lasciano violare sacrificando la propria vita, seppur nello splendore e con grazia.
Ad approfondire il tema sociale è stato Jan Švankmajer, al quale dobbiamo un’ulteriore straordinaria ripresa del motivo cannibalico in un cortometraggio surrealistico del 1992. Con l’ausilio della plastilina animata e della stop motion – ma senza ricorrere al dialogo –, Švankmajer mostra diverse classi sociali e uomini che si nutrono letteralmente l’uno dell’altro (o nell’altro). L’opera si sviluppa in tre segmenti, “Breakfast”, “Lunch” e “Dinner”, per mettere in scena il pasto della classe operaia, della borghesia e dell’élite. L’idea che l’uomo debba divorare l’altro per sopravvivere appare come una crudele ovvietà, ma non si tratta solo di sfruttamento tra chi ha tanto e chi non ha nulla: il tema è qui l’annichilamento reciproco, per i ceti più bassi, e la sopraffazione dell’altro per la sopravvivenza propria, nel caso di chi è più agiato, anche di poco.
Al rivoltante pasto animato del regista ceco passiamo, infine, all’abbuffata nostrana. Marco Ferreri chiude il cerchio. Nel 1973 esce nelle sale La grande abbuffata, pellicola franco-italiana discretamente nota. Quattro amici, interpretati da Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni, Philippe Noiret e Michel Piccoli (i cui personaggi sono deliziosamente omonimi), a cui si aggiunge una donna, Andréa Ferréol, amante di tutti e quattro, si rinchiudono in una villa, una sorta di hortus conclusus nel centro di Parigi, dove consumeranno vivande ricercatissime, alcool e rapporti sessuali con lo scopo di morirne.
Il film sembra mescolare il tema dell’amore fraterno tra i protagonisti all’amore per la vita. Siamo ben lontani, però, da un inno all’esistenza. Si tratta, piuttosto, del trionfo dei suoi epifenomeni, cioè degli elementi accessori della vita, delle vane vanità: questo è suggerito da Michel in una scena, che cita contestualmente anche la massima biblica “Vanitas vanitatum et omnia vanitas” (Ecclesiaste 1, 2; 12, 8).
Nella villa, ogni giornata è consacrata a dimostrare che il valore non è nella struttura (l’ideologia, la fede, il lavoro), ma si cela in ciò che arreda l’esistenza (il cibo, il sesso e l’“allegria, allegria”, come si sente dichiarare a più riprese). Anche la musica manca quasi completamente in questo film, in cui riecheggia ossessivamente solo un tema (quello della colonna sonora composta da Philippe Sarde), perché la musica implica essa stessa una forma di impegno, foriera com’è di sensi strutturali e strutture intellettuali troppo profonde per rientrare nel gioco.
Non epicuree, le giornate dei protagonisti sono l’esibizione del ludus esistenziale, cioè dell’idea che la vita valga il gioco, la risata, la battuta, l’abbuffata, l’emozione di una macchina d’epoca che parte e che si possa far avanti e indietro sul vialetto della villa. Ludus e lusso sono due parole chiave, racchiuse a loro volta in due scene liminari: quella iniziale e quella finale.
All’inizio abbiamo Philippe maniacalmente attaccato alle mammelle della sua vecchia balia. Philippe stesso, alla fine, morirà tra le braccia del suo nuovo amore, Andréa, una sorta di controfigura ringiovanita della sua nutrice. Così come il seno della sua balia lo accompagna alla vita, il seno di Andréa lo dirige verso la morte: una dolcissima gelatina in forma di due grandi seni daranno il colpo di grazia a Philippe, che soffre di diabete.
La metafora cannibalica, qui quasi completamente sublimata, giunge all’estrema sintesi. Si ritorna al punto di partenza, l’allattamento. Nutrirsi dell’altro significa, per la vita e per la morte, autoconservazione.
Valeria Russo