Pubblicato il 20 Settembre 2025
Creare ex nihilo: perché è quasi impossibile cambiare
di Cesare Grisi

Come cambiare lo stato delle cose?
Gli artisti parlano di idea creativa. Tutti gli altri di idea salvifica, per venire fuori dallo stallo della realtà in cui vivono. Lásló Krasznahorkai, in Satantango, dice che è meglio restare rintanati nell’abisso del paludoso presente, perché fuori… chissà cosa ci attende. C’è un terrore panico verso ciò che non ha forma nella mente, verso ciò che il cervello non riesce ad immaginare.
Ah, il cervello, dice Jeff Hawkins in Mille cervelli in uno: il cervello si struttura imitando la realtà. Ma è già da un po’, con il famoso pattern recognition, che si pone il riconoscimento alla base del funzionamento della mente: esattamente ciò che cerca di spiegare Simon Baron-Cohen, quando parla del meccanismo dell’empatia, che Rizzolatti &Co. chiamano effetto specchio.
E, quando la realtà di fuori assomiglia troppo a qualcosa che abbiamo in qualche modo trattenuto dentro, ecco che il cervello l’analogizza, dice John Searle, anche a costo di distorcerla, e si fida, lo sventurato che si crede proprietario! specie quando il soggetto pensante non sa come funziona il proprio cervello ed è quindi incapace di fargli la tara.
Ma tutto questo porta ad una sola conclusione: restare davanti allo sconosciuto, all’incognito, senza riconoscimenti né immaginazioni: è terribile! Si pensi al terrore panico, ben celato dietro la sicumera del sentimento d’un’appartenenza esclusiva, che incute lo straniero, il diverso, il migrante…
Perché il cervello non spazia nel vuoto! Lo stesso Cartesio, al buio, immobile fino a perdere il contatto col suo corpo, coglieva l’atto del suo stesso pensare, che gli faceva capire d’essere… sì, però il suo cogitare non si strutturava affatto sul nulla, ma sulle cose (cielo, terra, luce, calore, dice lui stesso) che, non riuscendo a darsi altre spiegazioni, riteneva essere dono di Dio: da qui l’infinta querelle tra mente e corpo (res cogitans e res extensa) durata fino all’annichilente Antonio Damasio, che con uno statement rivelante la consustanzialità delle due cose, stigmatizzava l’errore di Cartesio. E Damasio è solo l’ultimo arrivato! C’è tutta la dottrina filosofico-scientifica (se non dici scientifica commetti peccato!) dell’olismo e dei suoi innumerevoli precursori, come Eraclito, Spinoza, avanti poi con Hegel, senza lasciare indietro la modernissima gestalt. E, con tutte le buone paci che, specie di questi tempi, si potrebbero auspicare… la questione non è mica risolta: c’è una nutrita schiera di studiosi, professori, ricercatori, fisici, ingegneri, che non cercano altro che d’applicar la teoria quantistica alla materia un poco più complessa, fino a ritener – col ripescamento di Cartesio – che la forma del corpo granulare non è altro che un’increspatura ondivaga del tutto di cui ogni cosa, perdendo la sua forma, torna a far parte. E qui anche i teorici del nirvana gongolano, nella fatica immane di liberarsi dall’attaccamento per liberarsi del samsara.
Ma su questo argomento, sia chiaro, non se ne esce: ne sappiamo ancora troppo poco. Non si può far altro che tener tutte le migliori porte aperte, continuare la ricerca e tenere duro: il rischio è di finir nella cialtroneria, o d’impazzire. Sta di fatto ch’è per tutto questo stato della questione che gli psicologi dello sviluppo, tra l’intuitivo e l’avveduto, prescrivono tassativamente per il bambino un environment rich of stimuli: perché hanno studiato – da John Locke e dalla sua tabula rasa, da Jacques Monod e dalla ferrea biologia genetica, primo elemento, e dallo studio degli evoluzionisti tutti che non fanno altro che battere sul condizionamento dell’ambiente, secondo elemento, e sull’epigenetica… che la creatività, di cui l’intelligenza è matrice, non vien mica fuori ex nihilo!
L’intelligenza, per svilupparsi appieno, ha bisogno di molti moltissimi dati di realtà su cui, per imitazione, abbiamo detto, si cimenta, aggiungendovi poi il terzo elemento, il più fondamentale: la creatività. Pensateci: l’evoluzione della tecnologia ha avuto un progresso esponenziale man mano che le conoscenze si son moltiplicate di numero e di complessità. Stavo per dire evoluzione umana, ma mi sono saggiamente trattenuto. È il nostro cervello che funziona così. Quindi? Quindi non c’è cosa più terribile di non poter immaginare, di non avere niente davanti agli occhi. Per questo il bambino va nel panico quando è abbandonato: non ha altri riferimenti per sopravvivere! E per questo l’adulto non diviene adulto quasi mai, quando da bambino viene abbandonato.
Non per altro motivo la realtà, la putridissima realtà, è tanto cara: perché, diceva Dostoevskij in Delitto e castigo: «a tutto s’abitua, questa carogna ch’è l’uomo!». L’uomo fa della realtà un assioma: non pensa mai fuori dalla realtà perché pensarsi fuori dal conosciuto è una tragedia. Da ciò ne deriva che la realtà, pure quando è disgraziata… è d’uopo che venga, dall’abitudine, rinforzata.
Per cambiarla bisognerebbe avere il coraggio d’immaginarsela diversa, e per immaginarsela diversa, dice Cartesio, sempre nel Discorso sul metodo, è necessario trovarsi «un altro alloggio»: ma dove, se non nell’intercapedine del terrificante nulla e nell’angoscioso pericolo di fallire? Pochi, pochissimi hanno avuto questo coraggio, rispetto alla proliferante massa, e su questi pochi è cresciuta tutta l’umanità: ma prima avversandoli, quei pochi, uccidendoli, imprigionandoli come eterodossi, poi impossessandosi della loro idea che rivoluzionava, capovolgendola, tutta la realtà.
Ma come funziona il ‘giochino’ dell’idea? Come avviene la creazione? Ritorniamo a Lásló Kraszahorkai, che peraltro è lo scrittore (sceneggiatore) del grande Béla Tar che sulla difficoltà di cambiare ci ha fatto dei capolavori, come Il cavallo di Torino allusivo a Nietzsche che sul tema s’è guadagnato la follia. Anziché macerar nel fango: fai la valigia e vai! Dove? Non si sa. Ad ogni passo ti registrerai in base a tutto ciò che sai, e ciò che sai a sua volta si ri-registrerà in base alla nuova situazione. È un meccanismo esponenziale.
Puoi fallire? Certo che sì. Ma cosa è meglio? Hai questo coraggio? Tutto è iniziato, d’altronde, dalla savana che ha diradato la foresta madre di ogni figlio che, magari s’è dimenticato, è figlio d’Africa. Dalla savana i nostri progenitori si son diffusi (ora si dice migrare) per cercare quello che nel luogo che li aveva partoriti non trovavan più. Sono stati fortunati? Molti, troppi, i più: no. Ma noi siamo figli del coraggio di cambiare di tutti loro. Un po’ meno di 100 chilometri per generazione, all’inizio, e s’è scoperto il mondo. E quel coraggio di scoprire il mondo ci ha aumentato a dismisura gli elementi sui quali poi noi siamo cresciuti a dismisura. Ma, creata una nuova realtà, scoperto ogni centimetro di Terra, resa più faconda la vita, ecco che l’antico terrore riprende piede, solo sopito, e riecco l’abitudine allo stallo che riscopre quanto sia difficile liberarsi degli istinti primordiali, come quello di aver paura di cambiare la realtà. La tecnologia, d’altronde, è solo un’illusione di progresso, ed è meramente usata per mantenere intatta la realtà fino a quando, completamente depauperata, non ci sarà più realtà, e ciò avverrà, come dicono tutte le fonti più accreditate, in tempo assai breve.
La zavorra di chi non ha il coraggio dell’immaginazione è troppo pesante, rispetto al tragico Lavoro degli esigui visionari dell’umanità. Evoluzione, come democrazia, è una questione di numeri…
Cesare Grisi




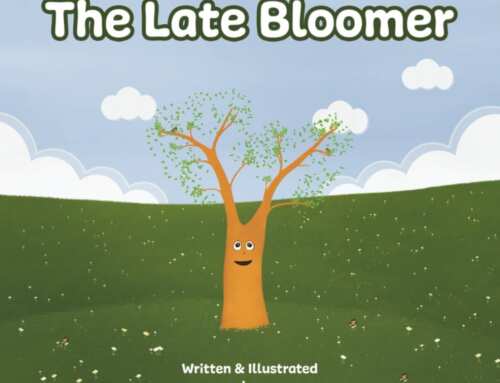







Rivista di Antropologia Culturale, Etnografia e Sociologia dal 2011 – Appunti critici & costruttivi