Pubblicato il 17 Novembre 2024
“Conosci Beirut ?”, Alberto Negri racconta il Libano
di Alberto Negri

Conosci Beirut? Mi dicevano i giornalisti più anziani con un sorriso intrigante, quasi malizioso, quando muovevo i primi passi in Medio Oriente. All’inizio degli anni Ottanta era già devastata dalla guerra civile, divisa dalla Linea Verde, oscurata dal fumo delle esplosioni e dagli incendi, il cielo di notte era costantemente attraversato dai traccianti dell’artiglieria. Nei notiziari andava sempre in prima pagina e dal 1975 aveva sostituito Saigon e il Vietnam caduti in mano ai vietcong. Bisognava sostituire i nomi dei generali asiatici con quelli di altri signori della guerra, cristiani maroniti, drusi, sciiti, sunniti, alauiti, palestinesi, che oggi, cinquant’anni dopo, ci sembrano familiari: un mondo nuovo ma antico stava entrando nelle nostre vite e non ci avrebbe più lasciato.
Beirut era la porta d’ingresso di un universo che ci aspettava da secoli, che poi nel Novecento abbiamo violentato con guerre e spartizioni, di cui molti forse vorrebbero dimenticarsi. Ed è ancora lì, nel terzo millennio, che ci attende, con un’altra guerra o con l’ennesimo rivolgimento.
Quasi tutti avevano un’amante a Beirut e tutti comunque, senza eccezioni, si erano fidanzati con la città stessa, da cui non potevano stare troppo lontani. L’infatuazione per Beirut affiorava scandalosamente nelle loro corrispondenze. Gli inviati di giornali e tv ci passavano sei, sette mesi di fila – allora i reportage duravano un’eternità – e di alcuni di loro conoscevo soltanto la voce al telefono o leggevo, oltre agli articoli, i messaggi sulla telescrivente. E quando tornavano raccontavano soltanto di lei, della città, ascoltavano le mie domande quasi con sufficienza, impazienti di tornare tra le braccia di Beirut. Anche i più anziani ed esperti ne erano perdutamente innamorati.
Tu, giovanotto, non potevi capire se non il giorno in cui ci saresti arrivato. E anche tu, mi avvertivano, saresti caduto ai suoi piedi. E quando avvenne davvero mi sembrava di conoscerla benissimo, e i suoi contorni – tante erano le descrizioni lette e sentite – mi parevano noti e scontati. Ovviamente era un tremendo inganno.
Ancora oggi, che pure la città cambia continuamente e si stravolge tra guerre, esplosioni e nuove colate di cemento, sento dentro i loro racconti, cerco alberghi e bar che non ci sono più se non nelle confidenze che mi avevano affidato: mi fermo ad angoli di strada scomparsi e scorro sull’agenda numeri di telefono che non risponderanno mai più. È come se mi avessero lasciato l’incarico di ricostruire con discrezione quello che avevano visto, sentito, provato, un bagaglio di emozioni e di storie che avrei dovuto custodire e maneggiare con cura. Beirut è anche una città di fantasmi e di lapidi funerarie.
Eppure quando ci arrivarono durante la guerra civile pure loro vivevano già di nostalgia, dei racconti di un’età dell’oro perduta che aveva raggiunto il suo apogeo alla vigilia di un conflitto interminabile che tra la primavera del 1975 e l’autunno del 1990 stritolò migliaia di vite e quasi la rase al suolo. In quell’epoca scintillante, continuamente rimpianta, il Libano era chiamato la “Svizzera del Medio Oriente”, un appellativo che oggi ci sembra paradossale, con le banche chiuse, la lira libanese in caduta libera e il Paese precipitato nel marasma di una crisi profonda. Il caos mediterraneo non ha mai fine.
Ma allora, durante la guerra, qualcuno della legione straniera dei giornalisti, aggirandosi tra le macerie, si era persino comprato una delle non tante abitazioni rimaste in piedi sulla Corniche e nelle vie laterali, oppure una rovina attraente, magari perforata dalle granate, da rimettere a posto, quando – un giorno – tutto sarebbe finito e loro sarebbero andati in pensione. L’idea era che, se fossero sopravvissuti a bombe e rapimenti, Beirut li avrebbe visti invecchiare sotto il suo sguardo complice e benevolo. Tutti riponevano una fiducia smisurata nella sua capacità di risollevarsi, una fede incrollabile, quasi una religione più forte di tutto il ventaglio di sette cristiane, musulmane ed eretiche, che affollano la cosmogonia libanese, continuamente ricordata dalle immagini sacre di santi musulmani o cristiani e nella sfilata dei cartelloni con i volti, assai meno rassicuranti, di capi politici e militari. Manovratori delle milizie, assassini e saccheggiatori senza distinzione di credo religioso, che nelle foto erano quasi sempre ritratti sorridenti e beffardi. Ed erano e sono ancora tanti, non come a Damasco e Baghdad dove dittatori come Hafez Assad e Saddam Hussein dominavano in solitudine da decenni ogni angolo dei loro Paesi. A Beirut si aveva la sensazione di un insano e sanguinoso pluralismo. Bastava controllare queste effigi e le scritte rivelatrici sui muri per capire in quale quartiere stavi arrivando.
Si cullavano tutti, ed è comprensibile sognare, nell’eterna e disattesa promessa della pace. Effettivamente un giorno la guerra finì. Per riprendere però mille altre volte ancora, tra attentati, scontri, migrazioni forzate, la “primavera” del 2005, i raid israeliani del 2006 e gli effetti devastanti anche in Libano della guerra civile siriana cominciata nel marzo del 2011 e mai terminata. A un certo punto erano un milione i profughi siriani radunati nei campi, che si aggiungevano a 500mila storici rifugia- ti palestinesi, quando Beirut era diventata la “capitale” dell’OLP di Yasser Arafat. Questa è anche una città di esiliati che riceve tutti.
Ma Beirut risorge sempre, almeno nei cuori di chi ama questo microcosmo arabo, esotico ma anche familiare. Non ho mai visto un amore così incondizionato, duraturo e resistente a qualunque scossone. Anche i suoi tradimenti, persino quelli più evidenti e incontestabili, venivano accettati, perdonati, giudicati fatali, ineluttabili, quasi doverosi. E il suo dolore diventava il tuo dolore. Beirut insomma non è una città, è una persona.
Alberto Negri
Continua a leggere il capitolo Beirut non è un città, è una persona in Bazar Mediterraneo, GOG Edizioni, 2021. Quest’estratto del libro Bazar Mediterraneo è pubblicato per gentile concessione dell’autore e dell’editore.
Nella foto, una facciata del Palais Sursock a Beirut, di cui Negri racconta nel proseguo del capitolo i cui interni sono stati distrutti nell’esplosione al porto nel 2020, come si legge in ques’articolo del The Guardian. La foto è del Jerusalem Post e di Vogue Italia che hanno riportato la storia di uno degli ultimi edifici rimasti a testimoniare la gloria del passato sofisticato di Beirut, Palais Sursock e la famiglia da cui discende Roderick Cochrane, uno degli attuali proprietari. Sua madre, Yvonne Sursock Cochrane era figlia di un libanese e di un’aristocratica napoletana Maria Serra di Cassano che stava prendendo il tè con degli amici sul terrazzo di casa al momento dell’esplosione. L’anziana signora, di 98 anni, è morta poche settimane dopo, come si legge anche nel racconto di The Gloss, la famiglia aveva da poco terminato il restauro completo del gioiello architettonico, racconta Roderick Sursock. Di fronte al palazzo sorge il Museo Sursock, dedicato all’arte contemporanea, il cui restauro post-esplosione è stato terminato nel gennaio 2023 anche grazie alla Cooperazione Italiana (ANSA).

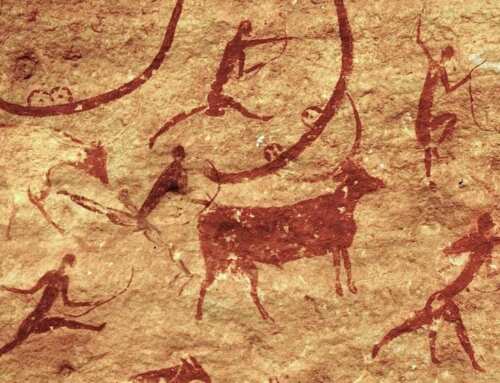









Rivista di Antropologia Culturale, Etnografia e Sociologia dal 2011 – Appunti critici & costruttivi