Pubblicato il 8 Aprile 2019
La cultura e la religione romanì, per saperne di più
di Giulia Bertotto

L’immagine che abbiamo dei rom è quella di residui umani che frugano nella spazzatura, rilegati in ghetti di baracche e degrado estetico e culturale. Un apartheid di privazione di opportunità sociali e professionali, disconoscimento di realizzazione economica e personale, negazione della possibilità di contribuire allo sviluppo della società umana.
Tradizionalmente la cultura romaní è invece caratterizzata da un forte senso del bello e della purezza, che si realizza in rigorose separazioni tra puro e impuro, onore e disonore, atti luminosi e atti oscuri. Queste distinzioni riguardano cibi, oggetti, parole e pensieri. Ma anche parti del corpo e fasi della vita. La nascita è pura ma il parto è impuro, così come la morte è da rispettare anche se il corpo del defunto è impuro. Dalla cintola in giù il corpo è impuro, dalla cintola in su, puro. Le mani per metà sono da considerarsi benigne e per metà maligne perché compiono sia gesti puri che impuri.
Per i rom Dio è identificato con la luce e il male con le tenebre. Questa ferrea dicotomia la ritroviamo nel Manicheismo di origine persiana che a sua volta nasce nell’humus culturale zoroastriano. Nel Manicheismo, l’esistenza dell’universo era concepita come il prodotto di una mescolanza orrida tra puro e impuro, un’ibridazione pre-cosmica tra le Tenebre maligne e corporee e la Luce immateriale, che coincide con Dio. Il manicheo aveva il compito di salvare Dio da questa prigionia e sé stesso da tale mescolanza insana. Le radici romaní affondano nell’India Vedica da cui trae anche il Manicheismo, ed infatti sia romaní che indù chiamano l’essere divino Deva, in sanscrito “luminoso”, potenza splendente. Queste comunità di cui spesso ignoriamo la ricchezza dei rituali e delle usanze, sono state un laboratorio sincretico in movimento nel loro viaggio millenario.
Nonostante il radicale dualismo della cultura romaní, questa divisione tra ciò che giova ed eleva e ciò che svilisce, non ha prodotto un rifiuto del mondo come nel buddhismo asiatico e nel Manicheismo persiano, ma anzi un gioioso senso di comunione con esso. La precarietà a cui questo popolo è stato sempre soggetto ha fatto sì che il dualismo non sfociasse in un rifiuto del piacere e dell’euforia. Dunque dal dualismo romaní non ha scaturito un disprezzo del mondo ma uno spiccato senso celebrativo di esso. Sperare nell’aldilà come luogo spirituale libero dalle contaminazioni del dolore e del divenire non ha portato a pensare alla vita come ad una trappola da cui svincolarsi. Anzi, i popoli rom osservano ogni ricorrenza e festeggiano la vita perché ogni momento può essere l’ultimo. La cultura rom è mossa dall’urgenza di vivere perché segnata dal pericolo incombente dello sterminio, così ha sviluppato un forte vitalismo, un colorato edonismo dato dalla drammatica instabilità della vita itinerante.
La vita ultraterrena è certamente la promessa di una condizione senza affanni e di consistenza ontologica superiore, ma quella mondana non ha perso valore per un popolo da sempre perseguitato. Un popolo che he ha cantato e lodato la natura e le bellezze del creato. L’idea che si vuole qui sostenere è che tra i complessi e diversi fattori sociali, ambientali e culturali che determinano l’identità di un popolo, il vissuto storico del nomadismo ha avuto come risultato quello di ammorbidire il distacco dal mondo tipico delle religioni dualiste come quella manichea e orientale avvicinando la religione romaní a quella cristiana. Infatti, mentre il Manicheismo ha liquidato la vita mondana come il prodotto patologico di un attacco delle Tenebre a danno della Luce, e il Buddhismo ha declassato la vita materiale a vana impermanente dei fenomeni e ha come obiettivo l’estinzione del desiderio e del ciclo del Samsara, il cristianesimo ha trovato il suo modo di mediare con la vita terrena.
Il cristianesimo ha salvato i fenomeni senza depotenziare l’aspettativa ultraterrena, e lo ha fatto attraverso l’incarnazione di Cristo. Il Creatore si è fatto creatura, la coscienza si è fatta materia, l’energia libera si è circoscritta nel tempo, rappresa nel corpo e collocata nello spazio, senza per questo perdere la sua sublime infinità. Il dispositivo trinitario permette ai cristiani di situare il mondo in una sorta di terza via ontologicamente ambigua ma conciliante, che certo non può competere con l’ultraterreno, ma non è neppure da deprecare.
Il cristiano ha trovato una sintesi tra svilimento del mondo e possibilità di viverlo attraverso il disimpegno ontologico del mondo, il “come se non” Paolino, quelli che usano di questo mondo, come se non ne usassero, perché la figura di questo mondo passa (1, Cor 7,31). Il cristiano ha formulato nell’incarnazione di Gesù il dispositivo ontologico per preferire il cielo senza disprezzare la terra, per praticare il mondo, il sesso e lodare il matrimonio anche se significa reiterare l’imperfezione a cui è sottoposta l’esistenza nel tempo e nel divenire. Paolo di Tarso infatti non ha proibito il matrimonio ma ha indicato che è migliore la castità. Il romaní ha vissuto il rischio continuo della scomparsa etnica e anche per questo ha salvato il mondo dalla condanna ontologica, e il cristiano lo ha fatto per mezzo del mistero dell’incarnazione.
Per motivi diversi entrambi hanno maturato una cura del mondo, una stima del corpo, un rispetto del moltiplicarsi e restare nel mondo. Dunque il nostro modo di venire a patti con l’esistenza è sicuramente più prossimo alle culture romaní e sinti da cui ci sentiamo tanto disturbati.
Giulia Bertotto
Giulia Bertotto è laureata in Filosofia all’Università La Sapienza di Roma e ha recentemente ottenuto un master in Consulenza filosofica e antropologia esistenziale.
Fonti per approfondire:
G. Gnoli, Il Manicheismo. Vol I, Mani e il Manicheismo, Mondadori, Milano, 2003.
“«La notte si trasforma in tenebre» Luce e tenebre nell’India antica”, di J. Scheuer, in Simbolismo ed esperienza della luce nelle grandi religioni, J. Ries e C. M. Ternes (a cura di), Jaca Book, Milano 1997.
In fotografia: Amedeo Modigliani, Zingara con bambino, olio su tela, 1919, Wikimedia Commons.

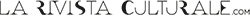




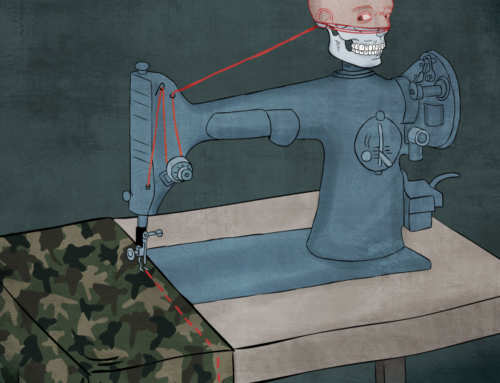





Rivista di Antropologia Culturale, Etnografia e Sociologia dal 2011 – Appunti critici & costruttivi