Pubblicato il 10 Aprile 2019
Vi racconto il mio Sudan
di Taghreed Elsanhouri

All’inizio del gennaio 2011, mentre il Sudan stava attraversando il processo di separazione, stavo girando Our Beloved Sudan, il mio documentario sulla secessione. In particolare, stavo intervistando Mohamad Wardi, famoso cantante e attivista politico. Wardi mi interruppe a metà dell’intervista e mi chiese: “Che mi dici di Ottobre? Dovrebbe andare nel tuo film”.
Wardi si riferiva ovviamente alla rivolta di Ottobre del 1964, quando il regime militare del generale Ibrahim Abboud fu rovesciato a seguito di una rivolta popolare. Nel gennaio 2011 le rivolte della Primavera Araba si erano diffuse da Tunisi al Cairo e molti speravano che in Medio Oriente le dittature riuscissero a trasformarsi in democrazie liberali grazie alle mani, ai piedi e alla voce della gente. Il Sudan però non fu toccato dalla “Primavera Araba”. Dissi a Wardi, “come può quell’Ottobre dare forma a questa generazione, puoi davvero confrontarci con la generazione che diede vita alla Rivolta di Ottobre?” Mi rispose “Perché no? Voi siete i pronipoti della Rivoluzione di Ottobre, ho fiducia nel popolo sudanese”, Wardi mi disse anche che “finché l’artista è in grado di creare, non invecchia”.
Se fosse vissuto più a lungo, Wardi con ogni probabilità avrebbe ri-arrangiato il suo famoso inno, Green October, composto in onore della rivolta del 1964, per questa nostra generazione dominata da WhatsApp e dall’hip hop, oppure ne avrebbe composto uno completamente nuovo e altrettanto trascinante. Me lo immagino mentre si dirige verso il Palazzo Presidenziale, chiedendo un incontro pubblico con Omar Al Bashir, leader de facto del Sudan dal 1989, per dirgli senza giri di parole che il suo comportamento è spiacevolmente non-sudanese. Il defunto cantante in vita aveva dimostrato di avere il coraggio impetuoso e l’audacia per portare avanti tali azioni. Sarebbe infatti stato fiero di tutti i giovani uomini e donne che sono scesi per strada, affrontando i proiettili vivi e intonando i canti: “Facciamola finita con i mercanti della religione” e “Pacifico, pacifico!”.
Le rivolte più recenti sono iniziate nella città di Atbara a metà dicembre del 2018, come conseguenza della rimozione del sussidio sul pane. Le manifestazioni si sono rapidamente estese fino alla capitale Khartum e ad altre città del Sudan. La perdita dei proventi del petrolio in seguito alla secessione dal Sud Sudan, la cattiva gestione dei fondi pubblici così come la caduta libera della sterlina sudanese dopo la fine delle sanzioni hanno fatto deragliare l’economia. La rimozione del sussidio sul pane e sul carburante, decretata dal governo, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Oltre alle cause più immediate delle rivolte, si nascondono tuttavia preoccupazioni più profonde: Al Bashir è al potere da 30 anni, il suo regime non è più in grado di rispondere ai bisogni più elementari della popolazione, le file per comprare pane e carburante abbondano e le banche hanno posto un limite massimo ai possibili ritiri di contante.
Alcuni analisti si riferiscono alle rivolte del Sudan come ad una Primavera Araba tardiva. Al contrario, i Sudanesi sono abituati a rivolte pacifiche e non violente, com’è stato il caso nel 1964 durante la presidenza Abboud e, successivamente, nel 1985 quando fu rovesciato il governo di Ghaffar Mahamad Nimeiri. Nei due casi, le manifestazioni popolari e pacifiche hanno fatto sì che le dittature militari fossero rimpiazzate da governi democraticamente eletti, anche se purtroppo di breve durata. La Rivolta di Ottobre del 1964 contraddistingue ancora l’identità di un’intera generazione sudanese. Dipinge l’immagine di un popolo che non ha aspettato che la Storia avvenisse da sola, ma quella di un popolo che è sceso per strada per scriverla. Green October, il famoso inno rivoluzionario di Wardi è un elogio alla volontà ribelle del popolo: “armati dall’Ottobre non indietreggeremo. Romperemo la pietra finché la pietra non ci darà dei raccolti verdi…nel tuo nome Ottobre, il popolo è vittorioso e i cancelli delle prigioni sono distrutti…”
Il panorama politico del 1964 e del 1985 non era però quello del 2019. La bussola morale sia di Aboud che di Nimieri non avrebbe permesso all’esercito di sparare sui manifestanti disarmati di Khartum. Entrambi i generali avevano le mani sporche di sangue ma era il sangue delle ribellioni armate portate avanti periferie meridionali e occidentali del Sudan, anche se questo non significa che in quelle periferie i civili non sono diventati obiettivi militari o non siano rimasti uccisi nel fuoco incrociato. “Tsqut bas” (“devi cadere”), il ritornello dell’attuale rivolta, è un rimprovero ad Al Bashir e al suo regime. Versare il sangue dei disarmati, dei manifestanti pacifici nella capitale è un evento senza precedenti, è un atteggiamento non-sudanese e per questo Al Bashir se ne deve andare, “tasqut bas”. Nell’Ottobre del 1964, Abboud accettò di dimettersi in cambio di un’amnistia per le atrocità di guerra commesse nel Sud del paese. Tutti quelli che, come l’imprenditore milionario anglo-sudanese Mo Ibrahim, chiedono oggi un’amnistia per conto di Al Bashir alla Corte Penale Internazionale, ICC, dove è attualmente ricercato per crimini contro l’umanità in Darfur, in cambio di ciò che rimane del suo potere, lo fanno nella speranza che possa facilitare una transizione pacifica in Sudan. “Che cosa direste ad una madre che ha perso un figlio in Darfur?”, chiese un giornalista della BBC a Ibrahim, “Io lascerei perdere le accuse presso l’ICC per salvare il suo secondo figlio”, rispose lui.
I politici occidentali così come i media mainstream non sembrano sapere come affrontare la narrativa delle rivolte del 2019, essa non rientra nella storia che spesso raccontano sul Sudan. Non ci sono scismi che dividono Arabi e Africani o Musulmani e Cristiani, ai quali si ispira la giusta rabbia delle celebrità Hollywoodiane che in passato hanno difeso la causa del Sud Sudan e del Darfur. Semplicemente è la storia della quotidianità del popolo sudanese proveniente da etnie e background diversi che dicono, per la prima volta dopo 30 anni, che è tempo di cambiare, di porre fine alla corruzione, la quotidianità di quel popolo che chiede e si merita un vero servizio pubblico e delle istituzioni capaci di servire l’interesse pubblico, invece di nutrire le tasche delle élites del regime.
Nel 2011 quando stavo girando Our Beloved Sudan ero alla ricerca di una narrativa che spiegasse il modo in cui i sudanesi parlavano di se stessi durante il processo di divisione del paese. Lo slogan popolare che emergeva da Omduran l’emmittente radio nazionale era “Siamo tutti fratelli e tutti Sudan”. Invece di riconoscere e tentare di sanare i risentimenti e le contraddizioni che spingevano il Paese verso la frammentazione, il portavoce ufficiale dello Stato stava cercando di attenuare queste contraddizioni con parole dolci ma prive di significato.
E’ debilitante e straziante essere testimoni da lontano, nella sicurezza della diaspora, delle immagini di giovani determinati con pelle bruciata dal sole picchiati dalle forze di sicurezza, uccisi da cecchini, o vederli dissanguarsi nelle braccia dei loro compagni. I messaggi WhatsApp dalla e sulla rivolta sono un barometro interessante della direzione del dibattito sul senso di appartenenza nazionale e su ciò che significa essere Sudanesi. Non è più uno slogan di comodo coniato da una radio nazionale, ma una conversazione che nasce nel sangue, nel sudore e nelle lacrime delle persone. Quando alcuni di noi esprimono i propri sentimenti riguardo alla brutalità delle braccia dello Stato ci ricordiamo che, nonostante questa violenza sia nuova a Khartum, è stata molto più frequente nelle periferie come il Darfur e le montagne del Nuba. La classe media di Khartum è forse rimasta bloccata nel passato, in quelli che Wardi chiama Alzamann Aljameel, i tempi bellissimi, ovvero i tempi in cui i dittatori come Abboud si tiravano indietro di fronte allo spargimento di sangue di manifestanti pacifici. Come presidente Abboud, aveva l’integrità e il coraggio di lasciare il potere, di mettere gli interessi del paese prima di quelli più ristretti del suo partito politico.
Il capitolo finale di questa rivolta è ancora da scrivere, però sia che Al Bashir resti o che sia rovesciato, la popolazione sudanese si sarà unita in una sola persona. La mia speranza è che qualsiasi progetto per ogni eventuale separazione futura del Sudan sia ritirato. Attraverso la loro sofferenza, le madri a Khartum condividono le stesse esperienze di dolore delle madri nelle remote zone di guerra. In questi tempi deplorevoli, coloro che sono al centro, così come colo che sono nelle periferie, stanno perdendo i propri figli a causa della brutalità dello Stato. Più di ogni altra epoca le condizioni per un dialogo onesto e riparatore sull’identità sudanese sono lontane.
Un successo degno di nota di queste rivolte è stato il rovesciamento della narrativa sull’Islam politico. All’inizio delle recenti manifestazioni, Ali Osman Mohamad Taba, Vice-Presidente del Sudan tra il 2011 e il 2013, in un’intervista per la Sudan Television annunciò che i figli e le figlie della Rivoluzione Islamica Sudanese erano pronti a dare la propria vita per salvaguardare il paese. Poche ore dopo l’intervista, su WhatsApp circolava una lettera eloquente scritta da un ex membro dello stesso partito nella quale si esprimeva un netto rifiuto per la proclamazione di Taha. “Non parli per noi”, si leggeva all’inizio della lettera. “Non siamo più il vostro esercito dormiente. Non moriremo più per i vostri fasulli slogan nel nome di Dio, come quando siamo stati ingannati e portati verso la Guerra Civile con il Sud. Lasci che siano coloro che hanno tratto profitto dalla Rivoluzione Islamica a difenderla”. Tanti detrattori dell’Islam politico e sostenitori del regime stanno oggi riconsiderando la loro posizione o si sono allontanati dal partito al governo. Tuttavia, se da un lato è sbagliato categorizzare la guerra civile in Sudan in termini di opposizione binaria come Arabi contro Africani o Musulmani contro Cristiani, sarebbe anche un errore guardare alle divisioni politiche che hanno portato alla recente rivolta in termini di contrapposizione tra Secolarismo e Islamismo. Il popolo sudanese è complessivamente religioso e osservante, per questo è più incline alle proposte dell’Islam politico. Le speranze per noi, che siamo all’interno dello spettro secolare del dibattito politico nazionale, risiedono nel fatto che negli ultimi 30 anni l’Islam politico è fallito moralmente e le persone sono sempre meno suscettibili alle sue influenze.
Riflettere sulle lezioni impartite dall’Ottobre 1964 potrebbe preparare questa nostra generazione alle opportunità che la rivolta offrirà per il futuro, se riesce a rovesciare il governo. Nel 1964 furono i sindacati e le associazioni di appartenenza professionale, come le associazioni di dottori o di avvocati, a guidare la rivolta, e insieme ne garantirono la coerenza, la disciplina e infine il successo attraverso la disobbedienza civile. Per questa attuale rivolta le persone si stanno organizzando grazie ai social media, in particolare tramite WhatsApp. Incredibilmente, i manifestanti si stanno sostenendo a vicenda per far sì che rimanga una protesta pacifica. Mantenere un atteggiamento pacifico nei confronti della provocazione violenta da parte delle istituzioni statali richiederà molta forza di volontà e disciplina, ma l’alternativa potrebbe essere il crollo e il collasso del Sudan. La lezione forse più importante del 1964 è rivolta alla leadership delle élites politiche sudanesi. La Storia si ricorderà di loro se, come nel caso di Abboud, decideranno di mettere al primo posto l’interesse del paese rispetto a quello ristretto del proprio partito. Sarebbe una parodia se uno o una coalizione della vecchia politica arrugginita nella forma di una giunta militare, i due tradizionali partiti settari – Umma e Itihad – o le varie anime dell’Islam politico si facessero avanti per ricevere i sacrifici della gente su un piatto d’argento.
Le rivolte riguardano le idee molto di più del malcontento politico e economico. I giovani che mettono a repentaglio la propria vita ogni volta che escono per strada per protestare meritano di sedersi al tavolo, meritano di essere parte attiva nel forgiare la nuova agenda politica. La solita stanca vecchia politica del privilegio, della religione, dei soldi sarebbe un tradimento nei confronti di coloro che hanno perso, o stanno perdendo, le loro vite per un Sudan migliore.
Taghreed Elsanhouri
Taghreed Elsanhouri è una regista e giornalista di origine sudanese nata a Londra ma residente a Khartum. La sua carriera è iniziata come reporter un’emittente inglese incentrata sul Medio Oriente e nel 2005 ha esordito come regista indipendente con il film All About Darfur, nel quale racconta il ritorno in Sudan durante la guerra civile che ha portato alla secessione del sud del paese. Ha poi realizzato le pellicole Mother Unknown (2009), un documentario sulle spose bambine di Khartum, e Our Beloved Sudan (2012) un racconto in chiave storica sul processo che ha portato alla separazione del Sud Sudan dal Sudan.
“Come regista afro-araba mi impegno a realizzare film che stimolino un coinvolgimento riflessivo rispetto alle sfide sociali, culturali e politiche che ci attendono” ha dichiarato al Festival di Berlino quando ha presentato il suo lavoro nel 2009.
L’articolo originale in inglese dal titolo Hopes for a Green October in Sudan è stato pubblicato per Africa is a Country, è possibile leggerlo qui.
In fotografia: la confluenza tra il Nilo Bianco e il Nilo Azzurro a Khartum.

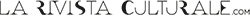




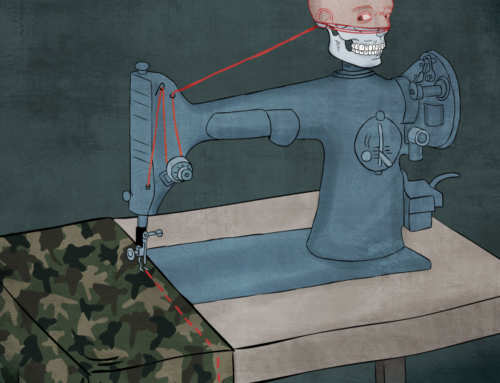





Rivista di Antropologia Culturale, Etnografia e Sociologia dal 2011 – Appunti critici & costruttivi