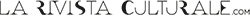Pubblicato il 6 Maggio 2021
Lacrime di cultura, come la cultura ci insegna a piangere
di Serena Gesiot

L’interesse antropologico si è spesso soffermato sull’essenza culturale delle lacrime, mostrando come il pianto non sia da intendere quale semplice reazione estemporanea e naturale, espressione universale di uno stato emotivo, ma piuttosto come un comportamento socialmente appreso, riflesso di rappresentazioni collettive situate. Le modalità e le aspettative relative al piangere vengono quindi incorporate attraverso processi di inculturazione capaci di togliere l’essere umano dalla sua plasticità originale, modellandolo secondo un ideale socialmente definito e approvato. La cultura, con la sua forza “antropopoietica”, seleziona uno tra “i mille tipi di vita” che in potenza ci sono dati, tesse quelle “ragnatele di significati” in cui ci troviamo sospesi e che ognuno di noi, nella sua esperienza di attore sociale, contribuisce ad intrecciare.
Le stesse emozioni, afferma la prospettiva costruttivista, non si possono pensare come fenomeni innati e puramente biologici, ma piuttosto, riprendendo Clifford Geertz, come “manufatti culturali”. La cultura emozionale non regola solamente la manifestazione dell’esperienza emotiva, ma ci permette anche di viverla come tale, fornisce gli strumenti e le risorse di senso attraverso cui interpretare e comunicare il proprio sentire. Così, mentre tra i Kaluli della Papua Nuova Guinea drammatizzare le emozioni era attitudine incoraggiata, a Bali, dove Gregory Bateson e Margaret Mead individuano uno stile emozionale in “stato di quiete”, gli atteggiamenti aggressivi erano fortemente disincentivati, se non addirittura stigmatizzati.
Le norme sociali disciplinano le forme, le circostanze e le figure a cui il pianto è concesso, negato o perfino richiesto. L’impostazione occidentale moderna tende ad associare le lacrime alla sfera della femminilità e della vulnerabilità. Similmente, nella tradizione indù dell’India settentrionale, mostra Jonathan Parry, l’espressione del dolore si strutturava secondo un ideale dicotomico di genere: l’uomo, dovendo aderire ad un modello “andropoietico” specifico, non poteva vivere liberamente il proprio sentire. Le donne invece erano quelle a cui era permesso piangere sulle tombe dei defunti e lasciarsi andare a violente manifestazioni di disperazione.
L’ideale di uomo-guerriero composto e austero perde però la sua supposta universalità una volta che ci si inoltra nella letteratura omerica: un mondo pieno di eroi in lacrime, che non temono di abbandonarsi al pianto di rabbia, di nostalgia e di gioia. Così nei villaggi solitari della Carelia russa e finlandese, lì dove era diffusa la tradizione del Lamento rituale, le donne erano credute “piangere con le parole” e gli uomini “piangere con gli occhi”. Le regole del pianto appaiono quindi plastiche, variabili, non universalmente valide, ma piuttosto strutturate secondo le rappresentazioni locali di genere e di status.
Sebbene lo stile emozionale occidentale tenda a confinare le lacrime entro la sfera del privato, vi sono diversi esempi etnografici di realtà sociali dove queste invece erano valorizzate e dotate di una finalità in qualche modo sociale. Un tipo di pianto che ha destato l’interesse di molti antropologi è quello che accompagnava i Lamenti funebri: le lamentatrici, attraverso il loro pianto ritualizzato, guidavano l’anima del defunto nel suo viaggio verso l’aldilà e contenevano il caos che la morte può innescare sia nella psiche individuale che nel tessuto sociale. Quella del Lamento era un’usanza presente trasversalmente, illustra bene Ernesto De Martino, una “difesa culturale” capace di consolidare le relazioni comunitarie e contrastare così le spinte centrifughe. Nella tradizione Careliana le lacrime del Lamento erano credute bruciare più del fuoco; per questo tutte le esperte rituali solevano tenere una stoffa bianca sul viso (Itkulina), così da proteggere gli spettatori dal loro insostenibile calore. Quello delle lacrime era una forma di linguaggio in grado di connettere il mondo dei vivi a quello dei morti, un sapere che solo una donna anziana, con il “cuore bruciato dal dolore”, poteva padroneggiare pienamente.
Nelle diverse culture non variano solamente i contesti e gli attori del piangere, ma anche i canoni e le modalità di esecuzione: nell’isola di Bubaque, tra i Bijagó, le lacrime per dirsi veramente “umane” dovevano adeguarsi ad una certa sequenza melodica, attenersi ad una certa estetica. Il pianto dei neonati, soggetti non ancora socializzati alle regole comunitarie, era considerato alla pari del verso degli animali: allo stesso modo i Gusii dell’Africa occidentale, racconta Robert Levine, dovevano seguire, nel piangere, uno stile melodico-ritmico definito.
Il pianto è un comportamento culturale che si apprende a gestire socialmente, che si impara a nascondere e ad enfatizzare a seconda del contesto e delle aspettative comunitarie. Sebbene quindi il piangere sia un’azione culturalmente influenzata, non si può dire totalmente determinata, proprio perché l’individuo è sempre in qualche modo anti-sistemico, imprevedibile, talvolta contraddittorio. Come sottolinea Chiara Pussetti, “culturale” e “appreso” non indicano necessariamente “falso” e “simulato’, non implicano un passivo adeguamento alla cultura emozionale: individuare un’impronta culturale nel nostro modo di piangere e di pensare il pianto non significa appiattire ed essenzializzare l’esperienza emotiva, ma piuttosto scorgere l’essenza relazionale del nostro “essere nel mondo”. «Se la vita è innanzitutto relazione sociale», afferma Antonella Caforio, «piangere o ridere in modo appropriato significa in primo luogo mostrare la propria umanità».
Serena Gesiot
Immagine: Armida Gandini, Gustose e dolcissime, installation view, vetro di Murano, Palazzo Bertazzoli (Bagnolo Mella), 2018. Courtesy of the artist, armidagandini.it