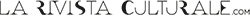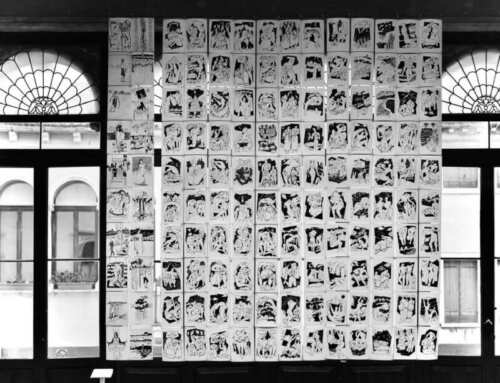Pubblicato il 2 Giugno 2024
Grazia Deledda e l’Edera
di Massimo Granchi

L’Edera di Grazia Deledda esce per la prima volta in tedesco e francese nel 1907 sotto forma di romanzo di appendice accolto in riviste di settore. È pubblicato in Italia nel 1908, prima a puntate sulla “Nuova Antologia”, periodico trimestrale di lettere, scienze e arti fondato nel 1866 a Firenze, e poi in un volume. La società sarda, fortemente strutturata in categorie sociali, è descritta dall’autrice attraverso il lento processo di decadimento di una famiglia aristocratica di campagna, i Decherchi. I ruoli dei molti protagonisti sono definiti con dovizia di particolari al fine di mantenere stabilità narrativa ed equilibrio, anche se trasmettono una condizione di perenne precariato: precario è il sistema economico, precaria è la politica locale, precaria è la salute fisica e mentale, precaria è la pace dell’anima e la vita stessa. La storia è ambientata nei primi anni del 1900 in un paesino immaginario denominato Barunéi; si tratta di una bidda, termine usato per indicare un paese o zona rurale.
Il testo ci permette di comprendere come la situazione descritta riguardi l’intera comunità barbaricina del tempo, compresa la stessa Nuoro, unico avamposto dove è possibile tentare di emancipare la propria condizione andando, per esempio, a servizio delle famiglie più facoltose. Nuoro non è ancora una cittadina, ma le ragazze di bidda, appunto, si spostano per cercare ospitalità presso le famiglie borghesi dove svolgono attività di teracca, domestica o addetta alle cure della prole, spesso di bambini poco più piccoli di loro.
Dal romanzo si desume che il capoluogo è un paese di 7.000 abitanti diviso in due parti, San Pietro, frazione dei pastori, e Sèuna, frazione dei contadini. È un avamposto remoto in una terra relegata a periferia del Regno d’Italia. La lingua italiana è un campo difficilmente praticabile e, in ogni modo, solo dai dotti, dagli istruiti formatisi presso le università di Cagliari e Sassari, vere città della Sardegna.
A Nuoro le scuole finiscono con il Ginnasio. Proprio la difficile accessibilità della lingua italiana, intesa come lingua dei colti, dell’autorità, del dominatore, è un primo marcatore della differenza culturale che porta alla trasformazione della cultura popolare sarda in cultura nazionale sarda. L’identificazione di sé passa attraverso il riconoscimento dell’Altro in quanto diverso e non comprensibile, ostile.
La propria affermazione è un processo che transita dalla legittimazione della propria esistenza. Franciscu Sedda ritiene che in questo i sardi convivano con la convinzione dell’assenza di una storia propria e sovrana che contribuisce a mantenere aperta la ferita del disvalore fino ad arrivare all’inesistenza tout court attraverso la mancanza di forma o di organizzazione delle pratiche culturali osservate e descritte, come per esempio avviene nel ballo.
Scrive Sedda a tale proposito: la descrizione di un rito soggetto al libero arbitrio dei singoli danzatori favorisce l’idea di una generale insensatezza dell’oggetto culturale e, più in generale, quella che è stata definita la costruzione semiotica del barbaro (Lotman 1985): è come se là dove viene svolta quella pratica non ci sia un senso comune e dunque nemmeno una vera comunità.
Deledda ottiene nel 1926 il premio Nobel per la letteratura, unica donna italiana a raggiungere questo traguardo proprio perché «ritrae in forme plastiche la vita quale è nella sua appartata isola natale e che con profondità e con calore tratta problemi di generale interesse umano». È quanto si legge nella motivazione del Comitato Nobel composto da membri dell’Accademia svedese. Una modalità per comprendere, dunque, il contributo antropologico dell’autrice nella caratterizzazione della cultura nazionale sarda, è descritta proprio in questo ultimo passaggio: la sua capacità di trattazione di problemi di generale interesse umano.
Pietro Clemente scrive a tale proposito che “la scrittrice è precisa nelle descrizioni di fatti culturali, di piccoli eventi, di forme proverbiali e di modi di dire, e che gli studi sulle tradizioni popolari le avevano lasciato una grande riserva di aspetti della cultura popolare cui fare ricorso nella scrittura dei romanzi”.
Massimo Granchi