Pubblicato il 16 Luglio 2022
Così non schwa
di Luigi Pavone

È da poco in libreria il libro di Andrea De Benedetti dal titolo «Così non schwa» (Einaudi, 2022). In un senso, l’impresa di costruire un linguaggio inclusivo è paragonabile a quella di alcuni filosofi del linguaggio di inizio Novecento, per i quali – semplificando ed esagerando volutamente – il progresso dell’umanità sarebbe dovuto passare per una lingua ideale, epurata da ambiguità logiche e semantiche. Oggi, in altro contesto e con altri protagonisti, si tratterebbe invece di purificare l’Italiano da un lessico e da una sintassi che presenterebbero elementi discriminatori nei confronti di persone che non si riconoscono nella dualità grammaticale maschile/femminile, le quali rivendicano un’adeguata rappresentanza linguistica per la loro identità di genere. Secondo la sociolinguista Vera Gheno e altrə, lo schwa sembrerebbe poter rispondere a quella istanza egualitaria. Che cosa sia lo schwa è abbastanza noto e un esempio è stato appena fornito. Si tratta di un morfema flessivo che intende introdurre il genere neutro nella lingua italiana.
L’Ideografia di Frege, per esempio, e il linguaggio inclusivo degli schwaisti hanno almeno questo in comune, che sono linguaggi artificiali che, nonostante le buone intenzioni dei loro ideatori, rischiano di imbrigliare le potenzialità espressive delle lingue naturali; e su questo rischio, il libro di De Benedetti è piuttosto efficace nel mostrare i limiti della proposta schwaista. In particolare, sull’introduzione dello schwa nel sistema morfologico della lingua italiana, il capitolo III presenta un’ampia analisi costi-benefici, alla luce della quale i costi sembrerebbero sorpassare di gran lunga i benefici. Da un punto di vista meramente sintattico, l’argomento principale contro lo schwa non è però decisivo. Infatti, quello della sacralità della costituzione linguistica dei parlanti non sembra sufficientemente laico. Più convincenti risultano gli argomenti basati sugli effetti stranianti della pronuncia di quel simbolo, sulla primarietà del parlato sullo scritto nei processi di cambiamento linguistico, sulla dispendiosità dell’introduzione di un terzo genere – il neutro – nella lingua italiana, sulle difficoltà che ampie fette della popolazione incontrerebbero nella scrittura e nel parlato dell’Italiano schwaizzato.
Ma è il capitolo II che cattura maggiormente la nostra attenzione, nonostante la sua apparente marginalità rispetto all’impianto teleologico generale del libro. Il nostro interesse per quelle pagine è motivato dal fatto che l’autore sembra voler riconoscere in esse la legittimità dei bisogni e delle richieste che stanno alla base della proposta schwaista. Insomma – non si può negare –, c’è una comunità di parlanti per la quale il binarismo grammaticale della lingua italiana è fonte di reale disagio. Ad essa è giusto dare risposte, e non solo proponendo uno spostamento dell’asse della riflessione linguistica dai significanti ai significati. Lungo questa direzione, l’autore sembra incidentalmente convergere, almeno in parte, con una nostra proposta metalinguistica (cfr. Le parole non hanno sesso, contro la moda dell’asterisco egualitario), sebbene in modi che a noi appaiono non ancora pienamente soddisfacenti.
A proposito del così detto maschile sovraesteso, cioè di quella regola per la quale nel riferirci a una pluralità (sessualmente) mista si usa il maschile, quella regola che per gli schwaisti ha il difetto di far scomparire le donne e le persone non binarie, scrive De Benedetti:
dal punto di vista morfologico […] il maschile rappresenta il prototipo, il paradigma, la […] matrice; il femminile è lo spin-off, il derivato, l’apocrifo. È in questo senso che va intesa la definizione di maschile come genere «non-marcato»: perché indica l’opposto del femminile e al tempo stesso lo ingloba, mentre il femminile si dice «marcato», nella misura in cui è più specifico e segna uno scarto rispetto al modello. Nella pratica, questo vuol dire che in alcune situazioni il maschile comprende/implica anche il femminile. (p. 27)
In altre parole, l’adozione del maschile nel riferirci a una pluralità mista non realizzerebbe una patriarcale dominanza del maschile sul femminile. Accadrebbe piuttosto che a essere impiegato sia un significato complesso che include sia il maschile sia la femminile. È questo genere di proposte che noi chiamiamo metalinguistico e/o didattico, in virtù del fatto che sposta il problema della (almeno percepita) discriminazione linguistica dal linguaggio al modo in cui lo descriviamo e lo insegniamo/apprendiamo. A giustificazione dell’interpretazione della regola del maschile sovraesteso nei termini dell’opposizione marcato/non-marcato, De Benedetti ricorda che «secondo i linguisti della cosiddetta scuola di Praga, la nostra mente tende sempre a distribuire in modo asimmetrico i significati in una coppia di opposti». Ciò sarebbe valido anche per gli opposti maschile/femminile. In pratica, la coppia maschile/femminile funzionerebbe in modo simile alla coppia alto/basso: come il termine «alto» include il significato di basso, p. es. quando si dice «Luca è alto un metro e settanta», pur essendo Luca tutt’altro che alto, così il maschile (non-marcato) include anche il femminile, p. es. quando si dice «Luca e Laura sono bravi alunni».
Questi opposti linguistici asimmetrici, a dire il vero, forse per il loro che di hegeliano o cabalistico, non convincono molto, e – cosa ancor più importante – sembrano non godere di sufficienti evidenze empiriche. E per i nostri scopi, pur spostando l’attenzione dal linguaggio al metalinguaggio, forniscono una condizione necessaria, ma non sufficiente per una piena soluzione metalinguistica. Infatti, sostituendo la sovraestensione con l’inglobamento non sembra che si facciano molti progressi: è preferibile per una donna essere sovrastata da o incorporata nel maschile? Non sarebbe allora forse più saggio dismettere del tutto l’uso delle categorie maschile/femminile nel descrivere e nell’insegnare/apprendere la grammatica e la morfologia di una lingua? Per i pitagorici i numeri pari avevano proprietà femminili, mentre i numeri dispari maschili, ma quale matematico oggi descriverebbe i sistemi numerici in quei termini? Non sarà che i linguisti siano ancora vincolati a un’epoca «pitagorica» della loro disciplina? Non ci sono in realtà ragioni forti per caratterizzare con termini di origine sessuale o di genere le forme grammaticali del linguaggio, le quali hanno piuttosto natura astratta e convenzionale.
Anziché parlare di genere maschile, si potrebbe allora più adeguatamente parlare di «genere grammaticale primario» o di «genere grammaticale 1». Il caso del riferimento a una moltitudine mista mediante il genere grammaticale che chiamiamo oggi «maschile» non sarebbe più descrivibile come una situazione in cui a persone di sesso o genere femminile si imponga (attraverso sovraestensione o inglobamento) il genere maschile, ma come una situazione in cui si usa quel genere grammaticale, quello primario (o come altrimenti lo si vorrà chiamare), che di fatto – estrinsecamente, tipicamente e storicamente – usiamo per oggetti che in natura hanno sesso o genere maschili.
Luigi Pavone
Laureato in filosofia con una tesi dal titolo Naturalizzare l’epistemologia. Considerazioni
intorno al modello pragmatista di Stephen P. Stich (2007). PhD. in filosofia del
linguaggio. Il suoi interessi di ricerca spaziano dalla metafisica analitica alla filosofia del
linguaggio e della logica. Ha pubblicato presso riviste specialistiche nazionali e
internazionali, come il Croatian journal of philosophy e il Logic and logical philosophy.

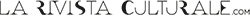





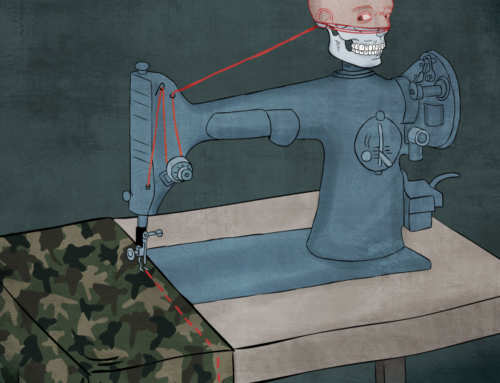





Rivista di Antropologia Culturale, Etnografia e Sociologia dal 2011 – Appunti critici & costruttivi