Pubblicato il 27 Gennaio 2025
L’olocausto come prodotto della modernità, l’analisi di Zygmunt Bauman
di Vincenzo Matera

Il nazionalismo, in una delle massime espressioni di “modernità” del secolo scorso, ha causato diverse catastrofi, fra le quali il triste primato spetta allo sterminio degli ebrei. Zygmunt Bauman, in Modernità e olocausto, Il Mulino, ed. 2010 ha analizzato l’olocausto in maniera particolare, mettendo in risalto come sia stato un prodotto di quell’organizzazione efficiente tipica della modernità.
Per Bauman infatti l’olocausto è stato un prodotto della modernità, e non una devianza da essa: la Germania, afferma Bauman, fece quello che fece proprio a causa di ciò che condivide con noi, e non di ciò che la differenzia. Quali sono i tratti che tutti abbiamo condiviso in quanto “europei moderni e nazionalisti”? Molti; per esempio, il sistema della produzione efficiente alla base della fabbrica modello; il potere della burocrazia; la scansione delle operazioni in fasi precise, stabilite dalle rigide gerarchie di comando, che agevolano la possibilità per i singoli esecutori di negare le responsabilità. Quindi, conclude Bauman, l’olocausto non è un fallimento della modernità, ma un suo prodotto.
Nella sua analisi dello sterminio degli Ebrei, Bauman rovescia uno dei corollari della sociologia di Durkheim, l’idea cioè che la società è un’istanza morale primaria: per Bauman il potere della società è esattamente opposto, nel senso che la società – una società solidamente “nazionalista”, impregnata di “una sola cultura”, può mettere a tacere le istanze morali dei singoli individui.
La gigantesca macchina di morte del nazismo lo dimostra (e, per quanto non paragonabili, lo dimostrano anche altre drammatiche vicende del Novecento, come il genocidio del Ruanda, per esempio). L’organizzazione sociale moderna zittisce il senso di responsabilità personale. Le sorgenti del comportamento morale non sono le istituzioni, non sempre almeno.
In uno dei suoi libri più importanti, in assoluto uno dei libri più importanti del Novecento, La banalità del male, la filosofa Hanna Arendt, nell’analizzare il comportamento tenuto da un criminale di guerra nazista durante il processo, dimostra la tesi di Bauman. Insistendo nel dichiararsi semplice esecutore di ordini, infatti, Eichmann è un esempio di come l’eseguire i doveri legati al ruolo occupato in un’organizzazione sia una procedura in grado di sciogliere le istanze etiche: la disciplina, il rispetto delle regole, la responsabilità “tecnica” dell’operazione sostituisce la responsabilità morale (o almeno fornisce lo spunto per sostenere la tesi di Eichmann, che infatti tutti gli esecutori di genocidi sostengono).
La consapevolezza della relazione tra l’azione e i suoi esiti verrebbe narcotizzata dalla procedura burocratica. Le conseguenze dell’agire non sono messe in conto direttamente all’agente, nemmeno nella coscienza dell’agente stesso.
Una tesi interpretativa un po’ diversa è quella sostenuta dallo storico Donald H. Goldhagen in I volonterosi carnefici di Hitler, Mondadori 1998, in cui l’autore si domanda come sia possibile che un uomo punti la pistola alla tempia di una donna inerme (o di un bambino, o magari di entrambi) e faccia fuoco, pensando di stare semplicemente “eseguendo l’ordine di un superiore nell’organizzazione”. Francamente, appare poco credibile.
Questo però nulla toglie all’analisi sociologica di Bauman, che coglie nello sterminio pianificato che i nazisti hanno realizzato con meticolosa razionalità su scala industriale, con orari e tempi e procedure dal tutto simili a quelle della produzione in fabbrica e per giunta entro la cornice ideologica della “pulizia” etnica, il simbolo di una congiunzione diabolica tra agire tecnologico e agire burocratico.
Nella modernità, il genocidio diventa elemento di ingegneria sociale, finalizzato a eliminare lo sporco, il disordine, l’ambiguità.
Il genocidio organizzato diventa così espressione estrema dell’essenza della modernità europea.
I sostenitori dei nazionalisti estremi farebbero bene a cogliere l’occasione rappresentata dal giorno della memoria per riflettere.
Vincenzo Matera
Pubblicato per la prima volta su LaRivistaCulturale.com il 27 Gennaio 2017
Immagine: Memoriale per gli ebrei assassinati d’Europa, Berlino, 2004 – progettato da Peter Eisenman. Fotografia Ullstein Bild//Getty Images

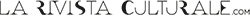









Rivista di Antropologia Culturale, Etnografia e Sociologia dal 2011 – Appunti critici & costruttivi