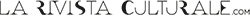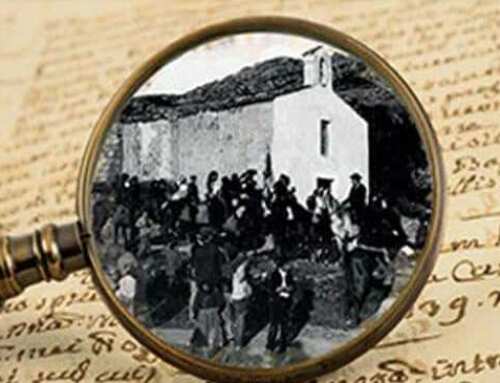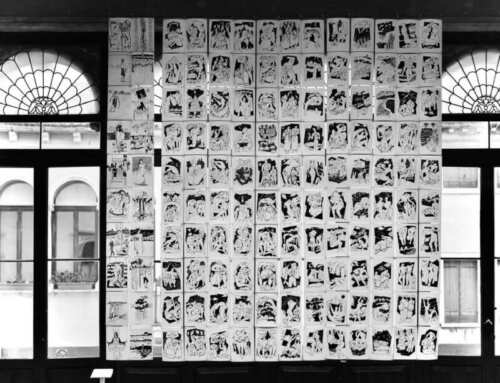Pubblicato il 16 Giugno 2024
Morte, pianto e lamento: plasmare la memoria per sopravvivere al dolore
di Andrea Ghidoni

Georges Didi-Huberman, nel suo ricchissimo libro dedicato al lamento funebre, Ninfa dolorosa: essai sur la mémoire d’un geste, 2019, che egli scompone ed interpreta da punti di vista estetici, antropologici, culturali, parlando del grido di protesta antipolitico che si leva dalle donne in lutto, sottolinea il bifrontismo temporale del gesto del pianto per i morti, poiché esso si colloca idealmente in un presente storico che diviene, per mezzo del compianto, “anacronico” (“meta-storico”, avrebbe detto Ernesto de Martino?), una intersezione tra passato e futuro, in cui queste dimensioni temporali sono in un certo senso compresenti: «il pianto funebre fa sorgere nel presente storico il momento anacronico di una memoria che supplica, di una memoria che desidera: cioè che esige dal presente stesso che si trasformi a partire dall’insorgenza vocale, invocata, della memoria dei morti» (p. 213).
Il lamento funebre sarebbe un gesto ancorato presso uno di quegli «isolotti d’immobilità che negano il tempo nella storia, ma che fanno il tempo della storia» di cui parla in suo articolo Nicole Loraux. Ciò significa che il gesto “universale” della lamentazione, anacronico perché giace su un fondo di immutabilità al di là delle sue forme particolari e storiche, è al tempo stesso uno spazio liminale da cui il lamentante esibisce un particolare desiderio fondato sulla memoria del passato e l’esigenza di trasformare più o meno radicalmente la realtà: il lamento per i defunti – come molte altre forme di agire culturale, secondo l’insegnamento demartiniano dischiuso in Morte e pianto rituale – esce dalla Storia per poter operare sulle strutture fondamentali della Storia stessa.
Così il lamento è definito mémoire qui supplie: da una parte, piangendo i defunti li si ricorda, retrospettivamente; dall’altra, questa rimembranza non è pura nostalgia, rimpianto, ma diviene desiderio, se non proprio esigenza, di una rifondazione del reale che però sia basata sempre sulla memoria del morto. Tale impellenza è «una esigenza fondamentale che non concerne la morte ma la vita a venire, la vita dei sopravviventi» (Didi-Huberman, Ninfa dolorosa, p. 214). Questo desiderio esigente formula altresì una prospettiva per il futuro, si fa progetto trasformativo.
Se dobbiamo individuare un terreno comune su cui far convergere i vari desideri espressi dai lamenti funebri, possiamo dire che l’esigenza più sentita dai sopravvissuti è quella del mantenimento della memoria: il defunto deve essere salvaguardato nell’aldilà affinché sia preservata la sua individualità così come essa è oggetto del ricordo di chi resta in vita; il defunto, se ne ha la facoltà, deve ricordarsi dei suoi cari; i sopravviventi devono conservare la memoria del morto attraverso atti rituali. In questo contesto, il lamento diventa davvero memoria che supplica, che domanda la propria sopravvivenza.
La memoria del defunto non è fine a se stessa, ma è piuttosto – nella prospettiva interna del lamento – un atto rituale che viene fondato in quel momento “meta-storico”, escatologico, in cui tutto sembra crollare a causa della morte della persona cara e di fronte all’esperienza del dolore. L’organizzazione della memoria del defunto è già di per sé un atto di plasmazione del comportamento dei sopravviventi rivolto verso il futuro, in quanto tale atto ipostatizza la persona storica del defunto secondo certi modelli culturali propri di ciascuna comunità umana. Al di là di questa plasmazione della memoria, che è nei fatti ma che può restare implicito, il lamento funebre spesso non si esime da forme di più o meno esplicita definizione di prospettive per il futuro dei sopravviventi. La forma del futuro nei lamenti funebri deve prendere in considerazione la ripresa delle attività umane dopo il lutto e tale ripresa non può che avvenire attraverso forme di sopravvivenza della memoria.
Innanzitutto, dobbiamo qualificare la dimensione temporale del futuro: mentre il passato è la dimensione in cui si godette della presenza del defunto nel mondo, mentre il tempo presente è la dimensione in cui si patisce l’assenza del defunto dal mondo, il futuro deve essere qualificato come la dimensione in cui si realizzerà la separazione tra il defunto e i sopravviventi. Anche la percezione dell’assenza della persona morta dà forma al futuro, che viene immaginato sotto il segno della catastrofe e della dispersione di ogni valore umano. Ma mentre l’assenza del defunto è una condizione che è subìta e che arresta l’agire culturale dell’uomo (il quale si riduce a forme del demartiniano pianto irrelativo, un dolore che non passa nel valore, nella cultura), la separazione è una condizione di distanza che può essere umanamente definita, regolata e istituzionalizzata, quindi pregna di valore umano. Poiché tale tempo è ancora di là da venire al momento del lamento, su di esso si possono proiettare soltanto desideri, esigenze, progetti. Lo strumento su cui è costruita questa separazione è precisamente la memoria: senza di essa la separazione diventa assenza.
In conclusione, abbiamo cercato di mettere in evidenza la componente legata al desiderio umano, che, di fronte alla prospettiva di un crollo, auspica per il futuro forme di protezione fondate sulla memoria: che l’oggetto della propria memoria sia salvaguardato in cielo e in terra; che il sopravvivente, dilaniato dal dolore, conservi la memoria di sé; che la memoria di una morte mitica possa salvare ciascun uomo dalla morte futura.
Andrea Ghidoni
Immagine Remnants collage dell’artista Doina Domenica Cojoracu-Thanasiadis, disponibile su Saatchi Art Online