Pubblicato il 11 Maggio 2024
La memoria dell’antropologo
di Vincenzo Matera

Con Ugo Fabietti abbiamo lavorato insieme per quasi venti anni. Su moltissime cose, editoriali, accademiche, di ricerca, di didattica, tutte finalizzate a alimentare l’antropologia, in particolare quella milanese che, quando abbiamo iniziato a collaborare, era inesistente. Lui insegnava a Pavia (da lì a poco sarebbe andato a Firenze), io non insegnavo da nessuna parte (da lì a poco avrei iniziato come docente a contratto a Pavia).
Siamo entrati in contatto per quella casualità che spesso tendiamo a interpretare a posteriori come una linea guida che orienta la nostra erranza, nella vita come nella ricerca e nello studio. Ma anche, ovviamente, per via di una convergenza di interessi e di sensibilità intellettuale. Da questa mescolanza nasce la memoria dell’antropologo, quella riflessione lunga che porta alla costruzione della propria antropologia – della propria visione del mondo, anche – grazie a ni ex-post, a letture, elaborazioni, ripensamenti, viaggi che si spandono nel tempo e nello spazio.
Il tema è rilevante non solo da una prospettiva, per così dire, personale e soggettiva, ma anche per quanto riguarda l’epistemologia antropologica, come Ugo ha sempre pensato, un’epistemologia della lunga durata. Oggi si assiste con perplessità e a volte con qualcosa di più – almeno per quanto mi riguarda – a una iperspecializzazione della ricerca e a una sua mercificazione sul mercato delle Università e di Centri e Istituti vari (Santoro 2017).
La ricerca, nelle cosiddette humanities, cambia pelle, perde progressivamente il radicamento nello studio e nel pensiero, nella riflessione meditata e sedimentata in lunghe durate, articolata e complessa e si sposta sul versante dello slogan vincente, degli abstract fulminanti che vengono premiati a volte con ingenti finanziamenti sulla base di procedure sempre meno adatte agli approfondimenti e sempre più modellate per quella che definirei instant research (non per la durata temporale ma per la scarsa profondità). Potrei fare molti – e sottolineo molti, che non significa tutti – esempi di ricerca-slogan, ben confezionata ma fondamentalmente inutile e concettualmente banale.
Niente di male, in tempi di vacche magre, come diceva Ugo Fabietti, a ciascuno il suo. Solo per sottolineare che l’affinità intellettuale che mi ha legato a Ugo Fabietti per tanti anni era fondata su un’idea della ricerca e dello studio un po’ diversa; diversa nel modo di mettere a fuoco un problema, di impostare un’analisi, di leggere un dato. Un’idea della ricerca e, più in particolare, dell’antropologia, che conservo anche oggi.
Tra le tante cose fatte, abbiamo scritto due libri insieme, che restano per me gli esiti di un periodo significativo della mia impostazione di studioso e del mio rapporto con Ugo Fabietti. Etnografia. Scritture e rappresentazioni dell’antropologia, pubblicato nel 1997 da La Nuova Italia Scientifica, poi Carocci, e Memorie e identità. Simboli e strategie del ricordo, pubblicato nel 1999 da Meltemi e ristampato nel 2018. Abbiamo fatto, ipotizzato, pensato, scritto anche molto altro, ma volendo scrivere del mio sodalizio intellettuale con Ugo Fabietti ho scelto questi due libri, emblematici della nostra lunga collaborazione vuoi per i risultati, vuoi per il lavoro che hanno richiesto e per gli insegnamenti che ne ho ricavato.
Li abbiamo scritti non ognuno al suo tavolo, alle prese con le sue parti, previa spartizione, non solo almeno, ma come esito di lunghissime conversazioni quotidiane, telefoniche e non, di incontri di solito nel suo studio a casa, durante i quali discutevamo di etnografie, di collegamenti, di scrittura, di antropologi del passato e di quelli contemporanei, di problemi di ricerca e di impostazione teorica, di filosofi utili e di quelli meno utili ad aprire percorsi, a costruire connessioni con il sapere antropologico, di scrittori anche, “etnografici” nel loro approccio all’esperienza, che nei loro romanzi avevano “rappresentato” un qualche aspetto di realtà sociale, intesa come il tessuto dentro il quale gli individui sono incastrati in un qualche “dove” e nel quale si sforzano di progettare la loro vita.
In quegli anni era da poco uscito per Einaudi Lo schiavo del manoscritto, che presenta una ricostruzione molto efficace della complessità, simile a quella cui va incontro un antropologo nel tentativo di cogliere e riprodurre una porzione di senso: i livelli narrativi, le sfumature semantiche, i posizionamenti politici e le interazioni delle soggettività emergono nettamente nel registro letterario e indicano una direzione di scrittura all’antropologo. Non è un caso infatti che Amitav Ghosh abbia studiato antropologia. Scegliemmo con cura gli autori da inserire e analizzare come esempi di forme di rappresentazione collegate a e derivanti da livelli di scrittura, sempre con riferimento a un pensiero teorico, a un principio chiave, a un’immagine del sapere costruito e a un’idea del senso e degli scopi della riflessione antropologica.
Discutemmo a lungo anche della cornice entro cui avvolgere i casi di scrittura analizzati. L’idea di riprendere il “quadrilatero etnologico” introdotto da Michel de Certeau (2005) – anch’egli un “errante” teso verso “l’alterità” – per “fissare” un certo tipo di oggetto epistemologico esito del sapere prodotto dall’antropologia per molti decenni nel corso del Novecento fu un‘idea di Ugo Fabietti.
Ci permise di collegare in modo molto convincente – secondo noi – la riflessione sulla scrittura alle modalità epistemologiche di produzione del sapere antropologico. La scrittura è un potente strumento nelle mani degli antropologi, le cui caratteristiche politiche, etiche, epistemologiche erano state dagli anni Ottanta ampiamente discusse (penso in particolare a Writing Cultures – Clifford, Marcus, 1986 e, in seguito, a Works and Lives, Geertz, 1990), e anche, nel mio piccolo, da me (Matera 1991, poi 2015).
La scrittura si manifesta nel lavoro degli antropologi a tre livelli principali, le note di campo, la monografia e il corpus etnografico, secondo un movimento circolare e ascendente espresso graficamente dalla figura del triangolo etnografico che, inserita dentro il quadrilatero di Certeau, arrivava perfettamente a descrivere le trasformazioni che gli antropologi imprimono al materiale grezzo del loro lavoro sul campo, pensandolo teoricamente, fino a modellare una rappresentazione sensata – secondo i canoni del senso narrativo propri della tradizione intellettuale e accademica occidentale. Le due figure geometriche, come aggiungemmo poi, si prestavano altrettanto efficacemente a delineare per contrasto le criticità che il dibattito decostruzionista aveva evidenziato rispetto al modello classico di costruzione del sapere antropologico: il fatto che tale modello poggiasse sul presupposto indiscusso che le società studiate dagli antropologi fossero astoriche, il fatto che l’antropologo fosse il solo soggetto in grado di dar senso all’agire in-consapevole dei nativi, il fatto che l’alterità venisse in un certo qual modo “addomesticata”, categorizzata in differenza, effetti tutti del potere proprio di chi detiene la scrittura.
Chi è privo di scrittura, senza che questo sia una colpa, un ritardo, una mancanza, un deficit, comunque la subisce; non solo i nativi rappresentati dagli antropologi, ma tanti altri (i migranti, i Rom – altre categorie di “marginali” – descritti dai giornalisti o di cui parlano i politici, per esempio). Ha scritto Edward Said nel suo celeberrimo libro che l’unica soluzione alla crisi della rappresentazione che ha investito l’antropologia a partire dagli anni Ottanta del Novecento sarebbe stata un ribaltamento del rapporto di potere fra l’Occidente e il resto del mondo (Said, 1973). Penso che con tutta probabilità sia vero, pur consapevole che tale veloce chiosa finale strida con l’enormità della questione, la quale del resto non può in questa sede essere nemmeno affrontata.
Come mi disse Fulvio Papi, quando andai a portargli una copia del volume appena uscito, con quel libro avevamo impresso e espresso un’idea molto personale della disciplina, una visione parziale e orientata. Non mi fu del tutto chiaro allora se dovevo prendere tale affermazione come un apprezzamento o una critica del lavoro. Forse come l’uno e l’altra insieme. Non ci avevo mai pensato a fondo, ma credo avesse ragione. In effetti, quel lavoro ha influenzato moltissimo la mia convinzione, maturata successivamente, che l’antropologia sia prima di tutto rappresentazione.
L’antropologo crea un ambito discorsivo, crea un modo di considerare problemi, eventi, conflitti, valori inquadrandoli entro una cornice. Che per far questo si avvalga di ricerca sul campo, oppure di altre fonti – o anche di nessuna fonte ricavata dall’esperienza – ciò che conta è la capacità di far presa della rappresentazione che ha costruito. In altri termini, la specificità del sapere antropologico sta nel modo di impostare i problemi, nel modo di pensarli e rappresentarli, non in quella che, senza apertura teorica, si riduce a mera “tecnica” di ricerca, né (ancor meno) nel “coraggio” dell’etnografo intrepido esploratore.
Non credo che Ugo condividesse in questi termini questa convinzione, né ho avuto più occasione di appurarlo, dato che l’ho maturata quando ormai i tempi delle discussioni e del lavoro insieme erano passati. L’esito al quale sono arrivato negli ultimi anni, insomma, quel “l’etnografia senza antropologia è il nulla” (Ingold 2007) esprime una critica alla “moda” etnografica che ha dominato il campo recente della mia disciplina, a quel ripiegamento in angoli di mondo dal quale poi pochi riescono a uscire in modo convincente, non banale, mantenendo intatto il filo rosso che sempre deve legare il micro lavoro sul campo alla macro cornice teorica. Questione di sensibilità, questione di predisposizioni, ovviamente: io ho sempre pensato che il lavoro sui libri – anche etnografici – fosse almeno altrettanto importante di quello con le persone.
Vincenzo Matera
Continua su Ledijournals Vincenzo Matera, La memoria dell’antropologo. Retrospezioni o interpretazioni ex-post, 2019.
In Per caso e per sagacia. Dialoghi con Ugo Fabietti, Vol.VI n.1/2019 numero della rivista Antropologia. Rivista fondata da Ugo Fabietti dedicata alla sua memoria, Ledizioni editore.
In memoria di Ugo Fabietti (Milano, 20 Novembre 1950 – 7 Maggio 2017), in Treccani

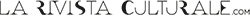




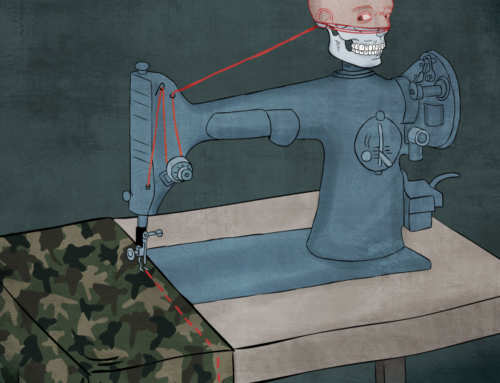





Rivista di Antropologia Culturale, Etnografia e Sociologia dal 2011 – Appunti critici & costruttivi