Pubblicato il 18 Febbraio 2026
Nati fuori binario. Raccontare l’infanzia e l’adolescenza transgender oltre il rumore del dibattito
di Sabina Pignataro

Quando ho iniziato a occuparmi di infanzia e adolescenza transgender, sei o sette anni fa, il tema affiorava sui giornali quasi esclusivamente in occasione di cronache traumatiche: violenze, conflitti familiari, controversie giudiziarie. Tutto il resto restava fuori campo. Restavano invisibili la quotidianità, le esitazioni, le sfumature. Come giornalista, durante una riunione di redazione mi fu chiesto di approfondire chi fossero davvero gli adolescenti transgender in Italia. Sembrava una domanda semplice. Non lo era affatto. Da un lato cercavo dati, cifre, statistiche robuste. Dall’altro ascoltavo storie.
I numeri erano frammentari, circoscritti ai centri clinici e dunque strutturalmente parziali: registrano chi accede ai servizi, tacciono su chi ne resta escluso. Le storie, invece, arrivavano con urgenza. Attraverso professioniste e professionisti incontrati negli anni, per passaparola, spinte dal desiderio crescente di famiglie e giovani di prendere parola in prima persona. La prima cosa che mi è apparsa evidente, fin dall’inizio, è stata questa: non esiste “il bambino” o “l’adolescente transgender” come figura uniforme. Ogni storia è irriducibile. E tuttavia, proprio nelle singolarità, emergono ricorrenze che permettono di leggere i nodi culturali, educativi e politici del nostro tempo.
Col tempo ho compreso che molte di queste conoscenze restavano confinate nella “bolla” degli specialisti. Mancavano strumenti chiari, accessibili, affidabili per un pubblico più ampio. Da questa lacuna sono nate prima la mia tesi di laurea in antropologia culturale, discussa nel dicembre 2024 all’Università Bicocca di Milano, e poi il libro Nati fuori dal binario. Infanzie e adolescenze transgender nell’Italia di oggi (Edizioni Il Margine). Scrivere ha significato, anzitutto, mettere ordine nelle domande.
“Perché oggi sembrano esserci così tante esperienze transgender?”
È una domanda ricorrente — forse la più insistente. Ed è una domanda seria. Per alcuni l’aumento di visibilità appare improvviso, quasi inspiegabile; per altri assume i tratti di una novità destabilizzante, talvolta percepita come allarmante. La prima precisazione è metodologica: in Italia non disponiamo, ad oggi, di dati solidi e sistematici sui minori transgender. Le cifre disponibili riguardano prevalentemente la popolazione adulta e registrano soltanto la porzione visibile del fenomeno: chi accede a un servizio sanitario, a un consultorio, a un reparto ospedaliero. Tutto ciò che resta fuori — esperienze non nominate, non diagnosticate, non intercettate — non entra nelle statistiche. La percezione di un’“esplosione” si costruisce dunque su un terreno in parte privo di basi empiriche affidabili.
Nel libro provo ad analizzare le ragioni di questa percezione, tenendo insieme piani differenti. Una prima chiave di lettura, a mio avviso particolarmente solida, è di ordine storico e culturale: le persone transgender non sono “comparse” oggi. Sono sempre esistite. Ciò che è mutato è la possibilità di nominarsi. In passato mancavano parole, spazi simbolici, modelli identificativi. Oggi, pur tra resistenze e conflitti, esiste una maggiore disponibilità di linguaggio. E il linguaggio non produce l’esperienza: la rende dicibile. La differenza è decisiva.
Una seconda dimensione riguarda i modelli culturali disponibili. Serie televisive, libri, testimonianze pubbliche, contenuti digitali offrono rappresentazioni un tempo assenti. Per molti giovani LGBTQIA+ il web ha costituito — e costituisce tuttora — uno spazio di sopravvivenza simbolica: un luogo in cui riconoscersi, rispecchiarsi, comprendere di non essere soli. Questo non genera automaticamente identità, ma può accelerare e rendere meno solitario il processo di consapevolezza. Dove prima dominava il silenzio, oggi esiste almeno la possibilità del confronto.
C’è poi una terza lettura, più ampia, che riguarda la trasformazione delle società occidentali. Il genere è divenuto uno dei campi privilegiati dell’esplorazione identitaria. In un contesto in cui riferimenti tradizionali — religione, appartenenza politica stabile, ruoli familiari rigidamente definiti — si sono indeboliti, la domanda “chi sono?” attraversa anche il corpo e la sua espressione. Questo vale in modo particolare per l’adolescenza, fase per definizione segnata dalla ricerca e dalla ridefinizione di sé. Alcune esperienze di varianza di genere sono profonde e persistenti; altre assumono un carattere più esplorativo, legato a questo passaggio della vita. L’eventuale transitorietà, tuttavia, non le rende illusorie.
Infine, vi è una dimensione politica e generazionale. Per una parte delle nuove generazioni, la difesa delle libertà di genere e sessuali rappresenta una forma concreta di impegno civile: una delle modalità attraverso cui oggi si declina l’attivismo. L’aumento di visibilità non si esaurisce in questo elemento, ma il desiderio di costruire uno spazio sociale più inclusivo ne è certamente una componente. Se dovessi sintetizzare, direi che non esiste una causa unica e lineare. Non è una moda, non è un contagio, non è un semplice effetto dei social. È un intreccio di fattori culturali, linguistici, relazionali e politici. È una trasformazione che investe il modo in cui una società rende visibili alcune esperienze.
E c’è un punto che rischiamo di smarrire: quando un adolescente trova il coraggio di dire “questa sono io”, “questo sono io”, “sto cercando di capire chi sono”, compie già un atto di verità. Forse, allora, la domanda decisiva per noi adulti non è “perché ce ne sono così tanti?”, ma “che cosa facciamo, noi, con ciò che ci stanno dicendo?”.
La questione del corpo
Nel dibattito pubblico la dimensione corporea viene spesso ridotta a una semplificazione polemica. In realtà, le esperienze di incongruenza di genere sono plurali e non sovrapponibili. C’è chi vive una condizione di disforia di genere — un disagio intenso legato alla frattura tra identità di genere e sesso assegnato alla nascita. In questi casi la pubertà può trasformare il corpo in un richiamo quotidiano a ciò che non si riconosce: le mestruazioni, lo sviluppo del seno, perfino gesti ordinari come il modo di urinare diventano marcatori di estraneità.
Altre persone, invece, non descrivono un “corpo sbagliato”, ma uno sguardo che lo interpreta in modo improprio. Non è il corpo in sé a essere rifiutato, bensì la lettura sociale che lo precede e lo incasella. Parlano di un “corpo letto male”. Le traiettorie di affermazione sono altrettanto differenziate. Alcune persone intraprendono un percorso medico di affermazione, he può includere terapie farmacologiche, trattamenti ormonali e, in età adulta, interventi chirurgici. Altre scelgono un percorso di affermazione sociale: modificano nome, pronomi, abbigliamento, modalità relazionali. Altre ancora non avvertono la necessità di intervenire sul corpo o sull’espressione, ma chiedono di essere riconosciute per ciò
che sentono di essere.
Per alcune persone transgender, intervenire sul corpo — attraverso una transizione sociale o medica — non equivale a negare la realtà biologica, ma a ridurre la distanza tra esperienza vissuta e forma visibile. Non si tratta di inventare un’identità, bensì di cercare una coerenza abitabile. Se, come ricordava Clifford Geertz, l’essere umano è un animale sospeso in reti di significato che egli stesso ha tessuto, anche il corpo si inscrive in queste trame simboliche. Non è puro destino, né pura volontà: è l’intreccio continuo tra natura e cultura.
In questo intreccio, il contesto pesa. Non determina tutto, ma incide profondamente. Può amplificare la frattura oppure attenuarla; può trasformare il disagio in solitudine oppure renderlo condivisibile. Anche quando non scioglie ogni conflitto, un ambiente capace di riconoscimento modifica la qualità dell’esperienza. Ed è qui che le parole diventano decisive.
Le parole dei ragazzi: quando il genere è esperienza, non teoria.
Se il corpo è uno dei luoghi in cui il genere si manifesta, è nelle parole che prende forma e chiede riconoscimento. È lì che l’esperienza smette di essere oggetto di dibattito e diventa voce. L’antropologia mi ha insegnato proprio questo: che ciò che conta non è soltanto ciò che viene dichiarato apertamente, ma anche ciò che si muove sotto traccia, nelle regole implicite, nei significati condivisi e mai esplicitati. È in questa prospettiva che ho imparato a spostare la domanda. Non più «cos’è naturale?», ma «chi ha stabilito che fosse così?». Interrogare l’ovvio significa riconoscere che ciò che appare immediato è spesso il risultato di una sedimentazione culturale. Anche il linguaggio con cui parliamo di genere non nasce nel vuoto: si apprende fin dall’infanzia — nei giochi, negli abiti, nei ruoli assegnati — e viene interiorizzato molto prima di essere messo in discussione. È dentro questa trama che i ragazzi cercano parole nuove per dirsi.
Tra le molte voci raccolte nel libro, una delle più giovani è quella di Chiara, nove anni, nata con il nome di Lorenzo. Racconta di non aver mai pensato di essere un maschio e di essersi sentita a lungo “sbagliata”. Poi trova un’immagine che non richiede apparati teorici: «È come quando indossi un paio di scarpe strette. All’inizio provi a camminarci. Poi fa sempre più male». È una metafora di limpida precisione. Vi si riconoscono almeno tre elementi: il tentativo di adattamento — camminarci comunque, ostinarsi a far funzionare ciò che non funziona; la natura non capricciosa del disagio — le scarpe strette fanno male, anche se sono eleganti, anche se tutti dicono che ti stanno bene; e la dimensione temporale — il dolore non irrompe subito, si intensifica quando non viene ascoltato. Le parole di Chiara riducono la distanza tra chi scrive e chi legge. Restituiscono concretezza a un’esperienza spesso trattata come categoria astratta. Per chi la vive, il genere non è un enunciato teorico: è quotidianità. È il nome pronunciato all’appello, il pronome che ti precede, lo sguardo che ti definisce prima ancora che tu possa parlare.
I ragazzi mi hanno insegnato questo: il genere è relazione. È il modo in cui si è visti, riconosciuti, attesi. E c’è sempre un momento — fragile e insieme decisivo — in cui qualcuno ti chiama in un modo che non ferisce più. Non è un gesto eclatante. Eppure cambia la qualità dell’esistenza.
Le famiglie e la “co-transizione”
Se il genere è relazione, allora anche il suo venire alla luce accade dentro una trama di relazioni. Nessuno si racconta davvero da solo. Quando un adolescente trova le parole per dire chi è, quella parola non resta sospesa: entra nella casa, si deposita nella memoria familiare, sfiora fotografie, nomi scelti anni prima, aspettative coltivate nel tempo. Ogni coming out non riguarda soltanto chi lo pronuncia: coinvolge l’intera geografia affettiva della famiglia. Nel libro utilizzo il termine “co- transizione” per descrivere questo processo condiviso: non attraversa una soglia solo chi prende parola sulla propria identità, ma anche chi gli sta accanto. La trasformazione, dunque, non è individuale: è relazionale. Madri e padri raccontano un “prima” fatto di fotografie, nomi scelti, proiezioni; e un “dopo” attraversato da domande, smarrimenti, ridefinizioni. Tra questi due tempi non si apre una frattura improvvisa, ma si distende un passaggio graduale. Accogliere un figlio che si racconta oltre le aspettative di genere non è un evento puntuale, bensì un percorso stratificato, fatto di avanzamenti e soste, di comprensioni progressive. È una trasformazione che richiede tempo.
Dentro questo tempo si colloca anche una fatica spesso taciuta. Molti genitori riferiscono di sentirsi giudicati più che sostenuti, soprattutto nei contesti scolastici e sanitari. La fatica è duplice: da un lato comprendere il figlio, dall’altro difendersi dall’idea implicita di aver “sbagliato qualcosa”. E tuttavia è proprio attraversando questa fase di spaesamento che può emergere un mutamento inatteso. Alcuni genitori, inizialmente disorientati e “senza vocabolario”, diventano interlocutori consapevoli, promotori di formazione nelle scuole, fondatori di reti territoriali. Ciò che nasce come smarrimento può trasformarsi in responsabilità condivisa. L’amore, quando non si irrigidisce nella difesa, può farsi gesto pubblico.
Lo fanno, in modo esemplare, le famiglie riunite in AGEDO — l’Associazione di Genitori, Parenti e Amici di persone LGBTQIA+ — nata per offrire ascolto, sostegno e informazione alle famiglie e per promuovere una cultura del rispetto nelle scuole e nei territori. Attraverso sportelli, gruppi di auto-mutuo-aiuto, incontri formativi e interventi pubblici, queste famiglie trasformano un’esperienza privata in azione civica. Non parlano “al posto” dei figli, ma accanto a loro. Rendono visibile ciò che spesso resta confinato nello spazio domestico. Non è un passaggio secondario. Dal punto di vista clinico e psicologico, il sostegno familiare costituisce il principale fattore protettivo: riduce il rischio di depressione, isolamento, abbandono scolastico e comportamenti autolesivi. Non perché elimini ogni difficoltà, ma perché offre una base stabile, una continuità affettiva che comunica, con semplicità essenziale: “Non sei solo”.
Restare nelle “terre di mezzo”
Molti genitori si trovano in una zona sospesa: tra ciò che credevano di sapere e ciò che stanno imparando a riconoscere. È uno spazio emotivamente complesso, una terra di mezzo in cui non si possiedono ancora tutte le parole. Ma forse il punto non è avere subito le parole giuste. Il libro Nati fuori dal binario. Infanzie e adolescenze transgender nell’Italia di oggi (Edizioni Il Margine) nasce in questa cornice di senso. Non si tratta né di un manuale, né di una guida. Non è nemmeno un libro militante. Non l’ho scritto per convincere, né per difendere o attaccare. L’ho scritto per provare a restituire complessità. È un libro per chi vuole capire. Per chi sente che le categorie non bastano più, ma non sa da dove cominciare. Per chi lavora con bambini e adolescenti e un giorno si è trovato davanti a una domanda nuova. Per i genitori che cercano risposte, e per quelli che non riescono ancora a fare le domande. Per gli insegnanti che ogni mattina incontrano storie che non stanno nei registri. Per medici, psicologi, operatori che vogliono ascoltare meglio. E, forse più di tutto, per i ragazzi e le ragazze. Per chi ha dieci, tredici, diciassette anni e si sente fuori posto. Per chi, ogni giorno, attraversa confini che alcuni pretendono fissi.
In poco più di cento pagine non porto certezze, né dogmi. Provo a fare una fotografia, non ideologica, di ciò che sta accadendo. Pur nella consapevolezza che raccontare è sempre un atto di interpretazione. Ogni sguardo è situato: lo diceva l’antropologo statunitense Clifford Geertz, lo ribadiva il filosofo francese Paul Ricoeur. Guardiamo il mondo attraverso ciò che siamo: la nostra storia, la nostra cultura, le parole che conosciamo. Nessuno sguardo è neutro. Neppure il mio. Sono una donna cisgender, bianca, occidentale, abile. Non è un limite da nascondere, ma un punto di partenza da rendere esplicito. Solo riconoscendo il proprio sguardo si può provare, onestamente, a incontrare quello dell’altro.
Sabina Pignataro
ANTHRODAY_WORLD ANTHROPOLOGY DAY_ TUTTI GLI EVENTI_LINK QUI
Presentazione a Milano
Di questo si parlerà venerdì 27 febbraio alle ore 18.30, presso la Libreria UBIK (via
Monte Rosa 91, Milano), in occasione del World Anthropology Day, durante un
incontro pubblico ispirato al libro Nati fuori dal binario di Sabina Pignataro,
giornalista e antropologa, in dialogo con Marco Grieco, giornalista.
Premio Inge Feltrinelli
C’è tempo fino all’8 marzo per votare il libro Nati Fuori Binario al Premio Inge
Feltrinelli, il riconoscimento internazionale in onore di Inge Schönthal Feltrinelli,
dedicato a valorizzare donne e nuove generazioni impegnate a dar voce a storie di
diritti negati, discriminazione e resistenza.
Il World Anthropology Day è un’iniziativa promossa dall’American Anthropological Association e lanciata a Milano (dal 2019), a Torino (dal 2023) e a Roma (dal 2026), dal corso di Laurea Magistrale in Antropologia Culturale e Sociale (ex Scienze Antropologiche ed Etnologiche), dal Dottorato in Antropologia Culturale e Sociale, dal Dottorato Patrimonio Immateriale nell’Innovazione Socio-Culturale e dal Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. La rassegna è organizzata in collaborazione con SIAA (Società Italiana di Antropologia Applicata), con il dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni dell’Università di Milano Statale, con il dipartimento di Studi Umanistici dell’Università IULM, con i dipartimenti di Culture, Politica e Società e di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino e con il dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo dell’Università di Roma Sapienza. Dal 2024 Radio Popolare è media partner; World anthropology Day si avvale anche del contributo organizzativo di Presso e della partnership con LaRivistaCulturale.com.



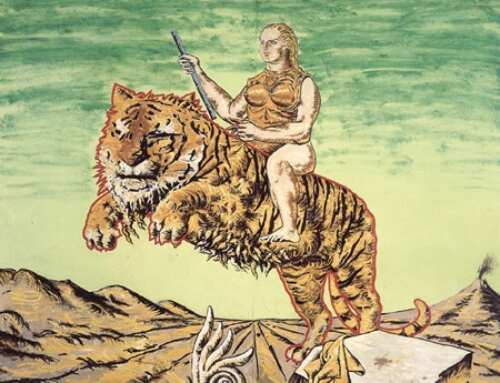







Rivista di Antropologia Culturale, Etnografia e Sociologia dal 2011 – Appunti critici & costruttivi