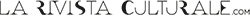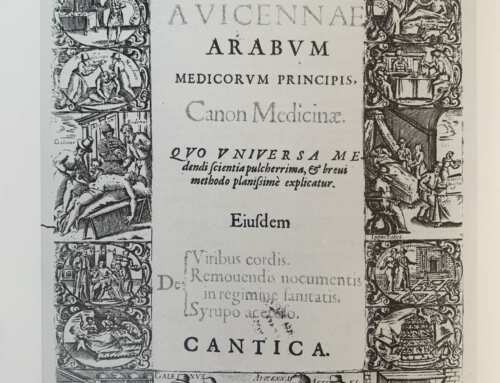Pubblicato il 18 Marzo 2021
Lavorare dentro l’identità o uscirne fuori?
di Francesco Remotti

Questo libro è dedicato alla memoria di Ugo Fabietti da parte dei colleghi italiani e stranieri con cui egli aveva costituito un attivo e assiduo gruppo di ricerca internazionale. Di comune accordo, si è deciso di scegliere l’argomento “identità” per le seguenti considerazioni. Il tema è di perdurante attualità, e Ugo Fabietti vi si era impegnato a lungo, fornendo contributi di grande rilievo in ambito etnografico, così come sul piano delle riflessioni teoriche. Negli scambi all’interno del gruppo i riferimenti al concetto di identità risultavano frequenti, come era normale attendersi, visto che anche altri, oltre a Fabietti, avevano prodotto scritti sul tema. Pur tuttavia, nessuno dei numerosi seminari che il gruppo annualmente organizzava a Losanna o in altre sedi è mai stato dedicato a questo concetto, così da farne oggetto di una riflessione comune. La consapevolezza di avere trascurato l’identità come tema di un confronto esplicito e di un aperto dibattito interno al gruppo è emersa, in modo evidente, in concomitanza con la scomparsa di Ugo Fabietti (7 maggio 2017). Per onorare la sua memoria e nello stesso tempo rimediare – sia pure tardivamente – a questa mancanza si è quindi voluto riattivare ancora una volta il gruppo, chiedendo a tutti i suoi componenti di intervenire sul tema dell’identità.
Di comune accordo, si è inoltre ritenuto di riascoltare la voce di Ugo Fabietti, ovvero di riavvalersi del suo pensiero sull’identità, riproducendo come primo capitolo un suo importante saggio sulle “Identità collettive”. Tutti gli altri capitoli – preannunciati nelle relazioni tenute in occasione del convegno dell’ottobre 2018 – sono stati invece concepiti e formulati in vista di questo ultimo incontro. In modi e gradi diversi, tutti gli autori fanno riferimento al pensiero sull’identità sviluppato da Fabietti. Il libro non è stato però concepito come un’illustrazione, un’analisi o un commento delle sue indagini antropologiche sull’identità. Gli autori formulano in piena autonomia le loro specifiche tematiche, essendo stati del tutto liberi di scegliere gli argomenti e gli aspetti ritenuti più significativi, ben sapendo che obiettivo del libro non è quello di offrire un contributo unitario, bensì una pluralità di punti di vista in relazione alla tematica prescelta.
(…)
Volendo dare uno sguardo panoramico a tutti i sei contributi confluiti nel libro, un aspetto sembra essere il più ricorrente, vale a dire la consapevolezza del carattere intrinsecamente problematico del concetto di identità. Sia pure in modi, stili e tonalità differenti, tutti gli autori si soffermano infatti non soltanto sulle tematiche sociali indicate, descritte o lumeggiate da questo termine, ma anche e forse soprattutto sulle difficoltà a cui questo concetto va incontro nel suo impiego sociale. In altre parole, tutti gli autori di questo libro si pongono la domanda: che cosa si deve intendere per identità? Quali sono i suoi significati fondamentali? Che cos’è che rende in sé così problematica e così discutibile questa nozione? Tutti i capitoli di questo libro possono essere esaminati, valutati e confrontati in quanto proposte di soluzione ai problemi che si annidano nel concetto di identità nel suo uso sociale.
Se ci soffermiamo sul contributo teorico maggiore fornito da Ugo Fabietti, vale a dire il volume L’identità etnica, è significativo rilevare l’espressione che egli aveva posto come sottotitolo: niente di meno che “un concetto equivoco” (Fabietti, 2013). A sua volta, Francis Affergan non esita a qualificare tale concetto come un “imbroglio”, cioè una sorta di “pasticcio” (secondo il significato che il termine ha in francese), pur senza escludere una qualche intenzione di imbrogliare le carte da parte di chi fa uso di una parola così impegnativa qual è appunto identità. A leggere i saggi qui raccolti, questa è in effetti la prima sensazione che si ricava: vale a dire una sorta di disagio che il concetto suscita e dunque la necessità di porvi rimedio apportando correttivi o integrazioni.
Nella Prefazione alla terza edizione di L’identità etnica, Fabietti forniva questa soluzione: l’identità – in particolare l’identità etnica – non è altro che “una costruzione culturale contingente, storica […] dipendente da contesti caratterizzati da rapporti di forza tra gruppi”. L’equivoco nasce se per identità “si intende qualcosa che è sempre uguale a sé stesso”: il correttivo che occorre apportare è che invece si tratta pur sempre e soltanto di una “costruzione”, in particolare di una costruzione storica e quindi soggetta al cambiamento. In modo analogo, l’equivoco sorge quando all’identità (in particolare all’identità etnica) si attribuisce un “alcunché di ‘naturale’, di ‘eterno’ […] di ‘sacro’, di ‘superiore’, di ‘eletto’” (che corrisponde al “sempre uguale a sé stesso”): e il correttivo consiste nel ribadire che si tratta “solo” di “un processo di continua riformulazione dell’identità”.
Qui però si annida un altro possibile equivoco. Se l’identità non ha alcunché di sacro, se l’identità è nulla più che una costruzione culturale, contingente e storica, dobbiamo forse pensare che l’identità – il pensiero dell’identità, il ricorso all’identità (indipendentemente dai suoi contenuti) – sia anch’essa un prodotto storico? Un qualcosa che compare in questa o in quella tradizione storica? Oppure è qualcosa di irrinunciabile, un qualcosa di cui non si può fare a meno, anche se di volta in volta ricostruito? Nel suo L’identità etnica Fabietti sostiene a chiare lettere: “non si può vivere senza identità, individuale o collettiva che sia”. Il che corrisponde bene a quanto egli aveva affermato in un passo precedente, e cioè che gli esseri umani sono “istintivamente etnocentrici”, ossia non possono evitare di porre al centro delle loro visioni del mondo la propria cultura, la propria società, il proprio “noi”: in quanto etnocentrici, essi non possono fare a meno di costruirsi e far valere una propria identità. Insomma, l’identità non ha nulla di sacro, perché è una costruzione storica, nulla di naturale, perché è un’elaborazione culturale: i suoi contenuti sono storici, in quanto essa viene di continuo riformulata, e tuttavia gli esseri umani e le società umane non possono esimersi dal farvi costantemente ricorso. In sintesi, gli umani sono esseri identitari, formulatori e costruttori di identità. Ma tipi e forme di identità non sono altro che prodotti storici e culturali, variabili nel tempo e nello spazio, frutti impuri – potremmo dire – in cui si mescolano contenuti e temi locali, interessi particolari, visioni diverse del mondo, della vita, della società.
Compito degli antropologi e in generale di coloro che si occupano di scienze umane è allora quello di sbrogliare le matasse dei pasticci e degli imbrogli, di chiarire come avvengono i processi di costruzione dell’identità liberandola dalle incrostazioni e dagli equivoci, di correggere le visioni unilaterali e astratte dell’identità (siano esse prodotte dagli attori sociali o dagli studiosi). Si tratta in fondo di un’operazione di riconoscimento e di messa a fuoco del carattere “complesso” della problematica identitaria e, nello stesso tempo, di un’operazione di salvataggio di un concetto necessario e indispensabile, di cui si ritiene di non poter fare a meno: non ne possono fare a meno gli attori sociali, così come non ne possono fare a meno coloro che intendono osservare e studiare gli esseri umani in situazione. Il concetto di identità viene dunque colto non già in un cielo metafisico, bensì nel frastagliato e variegato mondo umano. Indagata nelle società umane, non può più essere l’identità di un Parmenide, di un Platone, di un Aristotele, l’identità fissa, stabile, permanente, vagheggiata dalla tradizione filosofica occidentale. Antropologi e osservatori sociali vedono nel mondo una ben altra identità: un’identità che, a causa dei processi storici, così come degli ininterrotti dialoghi e scambi intersocietari, viene di continuo riformulata e ricostruita. Rispetto al concetto limpido, inequivoco, astratto, socialmente inapplicabile, della tradizione filosofica, ciò che essi vedono è un concetto inevitabilmente sporco, in certa misura equivoco e pasticciato, e proprio per questo bisognoso di una formulazione teorica adeguata.
Questo sembra essere, in effetti, il prezzo della sua esistenza concreta, della sua funzionalità e operatività sul piano sociale, soggetto com’è a usi e interpretazioni di vario genere. Ma, anziché lasciarlo in una condizione di “imbroglio” o di “pasticcio”, il compito che gli autori di questo libro si sono posti (in particolare, gli autori dei capitoli che vanno dal primo al quinto) è quello di rielaborare il concetto, così da farne emergere il senso sociale, le motivazioni profonde nei vari contesti storici o etnografici, la sua fruibilità sul piano culturale, così come su quello dell’attualità, in definitiva la sua plausibilità antropologica. Si potrebbe probabilmente dire che gli autori dei primi cinque capitoli partano dal seguente presupposto: se noi vediamo un impiego così diffuso del concetto di identità, vorrà dire che gli esseri umani affidano a esso buona parte del senso della propria esistenza (individuale o collettiva che sia). Compito dello studioso è allora quello di non fermarsi alla superficie del fenomeno, ma di affondare lo sguardo nell’imbroglio, di mettere le mani nel “pasticcio”, così da ricavarne i significati più rilevanti sul piano antropologico.
Impostata la questione in questo modo, i compromessi e gli equivoci, che tutti gli autori riconoscono, non sono più soltanto guai o malesseri semantici (secondo l’espressione di Affergan): divengono invece elementi apprezzabili, meritevoli di essere indagati, quanto meno sotto il profilo antropologico. Le stesse contraddizioni assumono, per così dire, un aspetto virtuoso. Per esempio, quando Fabietti afferma che gli esseri umani sono “istintivamente etnocentrici”, non si arresta di fronte a questa semplice osservazione. In quello stesso contesto egli parla di “un diritto alla propria identità” da parte delle società umane e, nel contempo, sottolinea tuttavia che queste stesse società hanno sempre mantenuto tra loro “rapporti assai più stretti di quanto non si pensi”. “Per quanto istintivamente etnocentrici”, e dunque promotori, costruttori e difensori di una propria identità, “gli esseri umani hanno da sempre sperimentato – anche se in certe epoche di più, in altre di meno – il dialogo e lo scambio”. Come conciliare queste due istanze, l’identità da un lato e lo scambio dall’altro? La conciliazione avviene complessificando e integrando l’identità, ovvero aggiungendo all’identità un carattere storicamente dinamico, proprio quel carattere che una concezione tradizionalmente filosofica non saprebbe riconoscere, in quanto sottrae l’identità alla sua matrice sociale e al divenire storico.
La complessificazione fa certamente correre a un concetto il rischio di apparire un pasticcio, un imbroglio, un equivoco. La domanda allora è: riescono gli antropologi a sostenere una concezione di identità così complessificata? Riescono a vincere la sfida della complessità a proposito dell’identità? Nel secondo capitolo Francis Affergan tenta esattamente di padroneggiare questo carattere complesso e difficile, proponendo una concezione di identità fruibile sotto il profilo antropologico. A questo punto, il discorso si fa ardito, obbligando i pensatori – antropologi o filosofi che siano – a provare a saldare in un unico concetto la permanenza e il mutamento: è così che si intende superare il senso del compromesso e il rischio dell’imbroglio o del pasticcio. L’elemento di forza dell’argomentazione di Affergan, che sotto questo profilo si rifà sapientemente a Immanuel Kant come a una sorta di “maestro degli antropologi”, consiste in una robusta e indefettibile presa di coscienza teorica del nesso tra permanenza e mutamento, nel senso che “le identità fisse e chiuse” risultano di continuo “attraversate da reticoli capillari e destabilizzanti”, mentre “le identità fluide e aperte” appaiono “costrette a riposare su una permanenza”.
Non si tratta però soltanto di una presa d’atto, qualcosa che sia oggetto di una mera constatazione. Analizzando quelle identità collettive che sono i “noi”, Affergan perviene al punto teoricamente più intenso della sua riflessione, là dove afferma che non è più questione di opporre la sostanza e il cambiamento (bouleversement). Le due categorie risultano infatti “intimamente mischiate [mêlées]”, e così la sostanza è il cambiamento e il cambiamento a sua volta diviene la sostanza in cui consiste “l’essere delle comunità umane”. La stessa cosa – aggiunge Affergan – si verifica per quanto riguarda la coppia identità/diversità: “ogni identità non può realizzarsi che nella diversità e viceversa”. La “dialettica del medesimo [même] e dell’altro [autre]” è dunque ciò che consente di superare opposizioni sterili, e proprio per questo offre all’antropologia la prospettiva più adeguata allo studio dei fenomeni umani e più promettente sotto il profilo epistemologico.
Potremmo dire, senza timore di sbagliare, che la “dialettica del medesimo e dell’altro” (Affergan), ovvero la “dialettica identità-alterità” (per usare l’espressione che troviamo subito dopo), è esattamente l’espediente teorico a cui tutti gli autori dei capitoli qui considerati (i primi cinque) fanno esplicito ricorso al fine di salvaguardare e rinvigorire il concetto di identità, ritenendo così di consegnare nelle mani degli antropologi uno strumento particolarmente efficace. In dialogo costante con Ugo Fabietti, Silvana Borutti fa infatti vedere come questo espediente sia indispensabile per evitare alcuni equivoci, tra cui soprattutto le trappole delle naturalizzazioni delle identità, quali si riscontrano non soltanto nelle pratiche sociali dei “noi”, ma anche nelle considerazioni scientifiche degli stessi antropologi. Questi equivoci e queste trappole si presentano allorché gli stessi antropologi si lasciano condizionare da ciò che Fabietti aveva definito l’“intelletto etnologico”. All’intelletto etnologico, che si accontenta di definire e classificare le etnie, inserendole così “in un orizzonte identitario irrigidito e privo di profondità storica”, viene opposta, evocando Hegel, una “ragione antropologica”, che senza dubbio trova nella dialettica identità-alterità la sua espressione più pregnante. Anche per Silvana Borutti, come già per Affergan, occorre dunque salvare il concetto di identità e a questo scopo è indispensabile riuscire a “pensare insieme” concetti opposti, quali sono la “trasformazione” da un lato e la “riaffermazione del sé” dall’altro.
Significativo è in questo capitolo il ricorso esplicito al pensiero di Hegel, il quale con la sua teoria del riconoscimento (Anerkennung) fa capire che i “noi” e gli “altri” non debbono essere intesi come soggetti o entità statici, posti gli uni accanto agli altri (secondo la tipica visione dell’intelletto etnologico, tabellesco e classificatorio): “noi” e gli “altri” si collocano invece in uno spazio fortemente e dialetticamente interattivo, segnato dalla “mancanza”, dal “desiderio”, dall’“appetito” (Begierde) dell’Altro.
Questo cercare sé stesso nell’Altro da parte di un “noi” potrebbe essere una suggestione molto valida per gli antropologi che rifuggono dal semplice incasellamento di etnie, gruppi, società (avremo modo di vedere riaffiorare questo tema nel quinto capitolo). Qui ci limitiamo a notare come l’attrazione per l’Altro sia funzionale a una concezione esplicitamente dialettica dell’identità, concepita come un “intreccio complesso e problematico” con l’alterità, tale da indurre l’antropologo, ancora una volta, a un “pensare insieme”, a mettere insieme elementi differenti: in questo caso, pensare insieme “l’identità e l’attraversamento” dei confini, l’identità e “il rapporto di scambio e traduzione con l’altro”. Su questa base, Silvana Borutti fa capire agli antropologi quanto sia importante esplorare modelli di “convivenza interculturale delle identità” e, su questa scia, come sia significativo intendere “il rapporto interculturale” come “un lavoro di rimodellazione continua del ‘noi’”, dunque – come già diceva Fabietti – una riformulazione costante delle rispettive identità.
Fin dall’inizio del suo saggio, Claude Calame si propone come l’autore che con maggiore determinazione si incarica di salvaguardare il concetto di identità da altri equivoci e imbrogli, cioè dai rischi delle compromissioni politiche e delle derive identitarie, rivendicando la sua applicabilità a cominciare dal piano personale (“l’identità in-dividuale” che occorre “riconoscere a ciascun individuo”), così come il suo carattere “complesso e fluido”, dovuto al suo continuo farsi e disfarsi. Che si tratti di identità individuali o di identità collettive, esse saranno sempre complesse, polimorfe, mobili, e come tali vanno non già interpretate come sostanze (secondo le tipiche derive identitaristiche), ma riconosciute mediante il binomio dell’imprescindibilità e della dinamicità. Anche qui – come già nei capitoli precedenti – assistiamo all’intento di saldare insieme l’identità-idem (quella della persistenza, riscontrabile nella costituzione biologica e personale dell’io) con l’identità-ipse (quella della mutabilità e della continua ricostruzione).
Perseguendo questo scopo, la strada intrapresa da Calame è la teoria dell’antropopoiesi, su cui l’intero gruppo aveva lavorato in diverse occasioni. A proposito dell’identità, che cosa offre tale teoria? Perlomeno i seguenti temi e aspetti: i) il presupposto secondo cui la costituzione biologica e neuronale dell’essere umano è “particolarmente plastica”; ii) l’affermazione per la quale l’identità si configura come l’obiettivo primario del lavorio antropopoietico, ossia del modellamento continuo dell’essere umano; iii) il tema di chi detiene sul piano sociale e culturale il potere del modellamento antropopoietico; iv) l’idea secondo cui l’identità, come può essere costruita e ricostruita, allo stesso modo può essere decostruita e distrutta.
Tenendo conto di questi aspetti teorici, Calame non soltanto si prefigge di salvare il concetto di identità, ma lo utilizza per descrivere in maniera particolarmente efficace il dramma dei movimenti migratori, pensando alle persone che hanno visto distrutto il loro assetto identitario a partire dai paesi di provenienza e alle quali molto spesso viene negata “ogni possibilità di ricostruzione dell’identità”. Se identità è qualcosa di cui ogni essere umano non può fare a meno, se l’identità – come suggerisce la teoria antropopoietica – si pone nel cuore della stessa umanità, se l’identità è un modo di esprimere nella maniera più pregnante i concetti di “dignità” e di “sviluppo della personalità” (art. 22 della Dichiarazione universale dei diritti umani), come sarebbe possibile privarsi di questo concetto? Solo perché è un concetto complesso, fluido, manipolabile, suscettibile di sporcarsi con equivoci, imbrogli e persino con derive poco rassicuranti? Non c’è forse il rischio di buttare via il bambino con l’acqua sporca?
Nonostante tutti gli sforzi finora compiuti dai precedenti autori per salvare e rinsaldare questo concetto, per portarlo all’onore del mondo e ripristinarlo come strumento indispensabile in mano agli antropologi, permane comunque una certa inquietudine, quasi fosse un insopprimibile rumore di fondo. Mondher Kilani è – fra tutti – l’autore che maggiormente fa emergere l’inquietudine dell’identità, come sua dimensione inevitabile e peculiare. Rifacendosi esplicitamente a Judith Butler, egli sceglie come titolo del suo contributo l’espressione Trouble dans l’identité, che in italiano abbiamo pensato di rendere con “Subbuglio nell’identità”. Del resto, non è solo trouble, ma è anche il termine subversion, che Kilani trae dal titolo di Butler. C’è dunque qualcosa che sovverte e che crea scompiglio o subbuglio nell’identità: un subbuglio che però per Kilani – in linea con il pensiero degli altri autori – non manda gambe all’aria l’identità, ma al contrario conferisce a questo concetto un senso nobile e tragico nello stesso tempo. Kilani ci parla del cannibalismo come dimensione intrinseca e inquietante dell’identità. Come non ricordare allora uno dei maggiori interpreti del cannibalismo, Michel de Montaigne (presente più volte nel contributo di Kilani), il quale definiva appunto come “nobile e generosa” la guerra cannibalica condotta dai Tupinamba del Brasile?
Kilani conferisce infatti un senso nobile a quella che egli chiama espressamente l’“identità cannibale”, ossia l’“identità aperta”, relazionale, l’identità dell’“inclusione” e dell’“inghiottimento”: un’identità “nutritiva”, fondata sulla reciprocità, sullo scambio simbolico, sull’interazione, sull’“incorporazione degli apporti esterni”, contrapposta all’“identità chiusa”, “mortifera”, ossessionata dal senso della purezza e dal conseguente rifiuto dell’Altro. L’incorporazione dell’Altro è esattamente ciò che provoca il subbuglio – e dunque il senso di inquietudine – di un’identità che “naviga tra sé e l’altro”, di un’identità “labile e incerta”, di un’identità non già semplice ed essenziale (come sarebbe la sostanza, nel tradizionale senso metafisico del termine), ma intrinsecamente molteplice e “composita”, di un’identità “nello stesso tempo trionfante e barcollante, unificata e molteplice, chiara e oscura”, di un’identità segnata dalla “incompletezza” e votata per ciò stesso al “cambiamento”, al “divenire altro da sé”. In questo modo Kilani recupera i temi della brama di alterità che erano affiorati negli ultimi tre capitoli di Contro l’identità (Remotti, 1996), che Ugo Fabietti aveva posto in luce allorché sottolineava l’imprescindibilità dei rapporti di comunicazione e di scambio tra i diversi gruppi, e che nel suo capitolo Silvana Borutti – come abbiamo visto – reinterpreta alla luce del concetto hegeliano di Begierde, fame, desiderio, appetito dell’Altro.
Ma questa metafora del cannibalismo applicata all’identità che cos’è? Un semplice espediente retorico? No. Per Kilani – come leggiamo nella conclusione del suo saggio – è uno “strumento euristico” che detiene un significato di “sovversione” nei confronti dell’identità: se da un lato si stigmatizza l’identità chiusa, fissa e mortifera, dall’altro lato appare un’identità tanto aperta alle differenze, tanto instabile e provvisoria, così eternamente incompleta, da rasentare – si potrebbe quasi dire – l’inesistenza. Con un’avvertenza, però, che Kilani ha posto all’inizio del suo capitolo e su cui possiamo registrare un accordo generale: per quanto illusoria o inesistente possa essere l’identità, “le azioni intraprese in nome dell’identità esistono in tutta la loro concretezza” ed è su queste che occorre richiamare “l’attenzione dell’antropologo”. L’identità in sé potrebbe anche non esistere: esistono però i suoi effetti.
(…)
Come si sarà notato, tutti i contributi finora esaminati (i primi cinque capitoli) condividono alcune tesi di fondo, che ora proviamo a sintetizzare in questo modo.
1. La prima tesi è l’imprescindibilità della nozione di identità, nel senso che – come affermava Fabietti – gli esseri umani non possono vivere senza identità, tanto sul piano individuale, quanto sul piano collettivo: ovvero l’identità (quanto meno la ricerca, il bisogno di identità) è connaturata all’umanità (alle società, così come alle persone umane).
2. Le identità possono tuttavia essere interpretate, concepite, costruite in vari modi: ci sono insomma vari tipi di identità. La tipologia usata dagli autori qui considerati è comunque organizzata sulla base di uno schema dicotomico oppositivo. Ogni identità risulta quindi essere: sostanziale o relazionale, forte o debole, chiusa o aperta, statica o dinamica, semplice o complessa, una o molteplice, fissa o fluida, stabile o mutevole, data o costruita, stabilizzata per un certo periodo oppure in continua costruzione (ovviamente, l’elenco è aperto).
3. L’identità è – per così dire – un oggetto nelle mani sia dei soggetti e degli attori sociali, sia di coloro che per professione fanno dei primi il loro oggetto di studio. In linea di principio, è quindi opportuno distinguere l’identità com’è concepita, costruita, vissuta, rappresentata, utilizzata, resa operativa da parte degli attori sociali (“io” e “noi”) e l’identità com’è invece concepita, rappresentata, teorizzata da parte degli antropologi e di altri scienziati sociali.
Facendo interagire queste tre tesi di fondo, potremmo dire che, in quanto esseri umani, anche gli antropologi non possono fare a meno dell’identità. L’identità non si riduce a essere qualcosa che si possa studiare soltanto sul campo, un “oggetto sociale” (Kilani) che l’antropologo incontra in questa o quella situazione e che poi studia dall’esterno: qualcosa che non gli appartiene, che non lo coinvolge direttamente. L’identità invece è un concetto connaturato nello stesso pensiero dell’antropologo, un concetto di cui l’antropologo non può privarsi: da semplice oggetto osservabile e analizzabile l’identità si configura quindi anche come strumento d’analisi, si trasforma in prospettiva di ricerca tipicamente antropologica.
È perciò inevitabile che gli antropologi incontrino l’identità ovunque, in qualunque società (dalle bande dei cacciatoriraccoglitori alle società globalizzate e ipertecnologizzate dell’età moderna) e che, in più, in quanto esseri umani, essi non possano pensare se non in termini di identità. Essi non lavorano soltanto sull’identità – l’identità trovata nelle loro ricerche sul campo o assurta a oggetto delle loro teorie. Essi ragionano o lavorano anche con l’identità ovvero mediante le categorie generate dall’identità. Nel saggio qui riprodotto Fabietti sostiene però che l’antropologo analizza una determinata realtà culturale “in base a presupposti concettuali diversi” da quelli che operano nelle menti e nei comportamenti di “coloro che di quella realtà fanno parte”. Questo vale anche per l’identità? Abbiamo già visto che neppure l’antropologo può fare a meno di ragionare con l’identità (tesi n. 1). In che senso allora l’antropologo si distingue dagli attori sociali (tesi n. 3)? Se ne distingue – potremmo arguire – in quanto si destreggia molto meglio con le categorie dell’identità, nel senso che può mettere in luce modi diversi di intendere l’identità, utilizzare tipi diversi di identità. È significativo che in tutti i cinque capitoli qui considerati venga fatto ricorso, in modo più o meno esplicito e sistematico, a una tipologia di forme diverse di identità, come quella presentata nella tesi n. 2, e che gli autori di solito privilegino i tipi dinamici, fluidi, complessi dell’identità, quasi a sottolineare che, mentre gli attori sociali potrebbero immaginare, rappresentare e tentare di costruire identità fisse, stabili, sottratte alla storia, ciò che i soggetti producono sono pur sempre identità complesse, soggette al divenire, costrette a certe aperture, nonostante tutti i tentativi di chiusura e di stabilità. Gli attori sociali rischiano spesso di immaginare identità ispirate alla fissità e alla completezza dell’essere, senza rendersi conto delle involontarie aperture all’alterità e al divenire, che invece si verificano sul piano pratico. Ponendosi da un altro punto di vista – partendo da “presupposti concettuali diversi”, oltre che da interessi diversi – gli antropologi si danno il compito di correggere e integrare questo tipo di rappresentazione, e quindi all’essere, quale principio di ispirazione di certe costruzioni identitarie, aggiungono il divenire, l’alterità, la complessità, quali elementi ricorrenti e praticamente indispensabili di ogni costrutto culturale. Un po’ come dire: gli attori possono anche tentare di costruire identità sulla base dei principi di stabilità e completezza, ma le forme di identità che essi riescono a costruire sono pur sempre caratterizzate dalle dimensioni della dinamicità e dell’apertura.
In questo modo l’antropologo, invece di uscire dal perimetro dell’identità, vi si insedia assumendo il ruolo di conoscitore e di grande esperto delle concezioni e delle costruzioni identitarie. Avvalendosi della tipologia descritta prima (tesi n. 2), che gli consente di considerare tipi diversi di identità, egli rivendica una visione non solo distinta e a parte, bensì una visione più potente e comprensiva, più articolata e completa rispetto a quella degli attori sociali (tesi n. 3), più incline quindi a “relativizzare le identità senza assolutizzare le differenze”, secondo la formula con cui si conclude il libro più volte citato di Ugo Fabietti. Si tratta pur sempre di identità, ma un conto è l’identità che si pretende chiusa e un altro conto è un’identità aperta, nonostante le pretese di chiusura e di completezza; un conto è un’identità che si vuole statica e un altro conto è un’identità dinamica che ingloba le esigenze della stabilità; un conto è un’identità che si ispira unicamente al concetto di sostanza e un altro conto è un’identità che sa di essere relazionale, nonostante la propensione a pensare sé stessi o gli altri come sostanze a parte, autonome, indipendenti. Rispetto agli attori sociali, l’antropologo si presenta dunque come colui che è in grado di vedere tutti i modi possibili in cui l’identità può prendere forma: oltre i due tipi descritti prima (identità aperta e identità chiusa, identità statica e identità dinamica), è pure concepibile la commistione tra i due tipi, che poi – a pensarci bene – sarebbe il modello di identità maggiormente ricorrente nelle costruzioni storiche e sociali.
È così che l’antropologo giustifica il suo ruolo e spiega il suo compito professionale, quello di dimostrare, rispetto agli attori sociali di questa o di quella società, che vi sono altri modi di intendere, organizzare e costruire l’identità: non già soltanto l’identità immaginata in base a criteri rigidi e unilaterali, come quelli della chiusura, della staticità, della completezza, bensì un’identità che nel suo manifestarsi storico si rivela aperta, dinamica, complessa; non soltanto quindi l’identità che respinge (come quella delle derive identitarie), ma anche l’identità che, in modo più o meno accentuato e consapevole, include gli altri, si nutre di alterità. “Identità complessa” è probabilmente la formula che, con maggiore efficacia e pregnanza, sintetizza la proposta elaborata ed esposta nei primi cinque capitoli, a cominciare dal saggio iniziale di Ugo
Fabietti: un “lavorare dentro l’identità” per farne uno strumento consapevole e fruibile tanto sul piano della società e della politica, quanto sul piano dell’epistemologia e del sapere antropologico.
(…)
Il lettore può tuttavia rendersi conto facilmente che in questo volume sono rappresentate due modalità diverse di affrontare il tema dell’identità. La prima – quella descritta finora nella sua programmata dialetticità e complessità – è una modalità interna, nel senso che intende mantenere il concetto di identità; muoversi nei meandri delle sue problematiche; salvarlo e riproporlo al di là e nonostante gli equivoci, i malesseri semantici, i pasticci, gli imbrogli, i subbugli, le inquietudini; rielaborarlo al di là di certe limitazioni, impoverimenti e interpretazioni unilaterali; offrirlo quindi rigenerato all’analisi degli studiosi o alle scelte dei soggetti e degli attori sociali e politici come strumento ricco e vitale, oltre che indispensabile. La seconda modalità è invece quella esposta nel sesto capitolo: una modalità volutamente esterna, in quanto si ritiene che per capire l’identità, le sue funzioni sociali, i suoi significati culturali, le sue presenze e incidenze storiche, occorra uscire dal recinto mentale dell’identità e acquisire un punto di vista decisamente esterno. Nel sesto capitolo l’autore – lo stesso che sta scrivendo questa Introduzione – ha spiegato il percorso che l’ha condotto da una prospettiva “interna” a una prospettiva “esterna”.
Se Contro l’identità (Remotti, 1996) era un libro nato dalle forti preoccupazioni per le derive identitarie, esso affermava tuttavia l’identità come principio irrinunciabile: andare “contro l’identità” non significava buttare a mare questo concetto, ma combattere contro una visione unilaterale e spingere verso una concezione che stringesse in un legame inestricabile identità e alterità. Se nel frattempo non avesse cambiato idea, l’autore di Contro l’identità sarebbe quindi stato del tutto d’accordo con le posizioni assunte dai colleghi che hanno scritto i primi cinque capitoli.
Con L’ossessione identitaria (Remotti, 2010) la visione cambia radicalmente: l’identità non è più un principio irrinunciabile. Si può fare a meno dell’identità. Essa si configura allora come un modo di pensare che ha preso piede in una determinata società (la società contemporanea), un modo di pensare diffuso, simile a un meme (per dirla con Richard Dawkins) che ha contagiato le menti, una sorta di mito collettivo che si è impossessato del nostro modo di vedere il mondo, la società, noi stessi, soggetti singoli o soggetti collettivi. In quel libro, si proponeva una doppia operazione agli antropologi: per un verso eliminare l’identità dalla propria cassetta degli attrezzi (l’identità non è più un explanans) e per l’altro verso collocare l’identità – i discorsi sull’identità, le ideologie identitarie, nonché le pratiche, le azioni, i movimenti ispirati all’identità – sul piano degli oggetti da indagare (l’identità come un explanandum).
Vi era però un problema lasciato aperto: qual è il terreno su cui collocarsi per studiare adeguatamente, e dall’esterno, l’identità come fenomeno culturale? La risposta a questa domanda è stata ricercata attraverso una laboriosa indagine, che ha trovato il suo esito in una parola: “somiglianza”, o meglio ancora nel binomio “somiglianze e differenze” (Remotti, 2019a). La tesi è che, se si vede il mondo come un intrico di somiglianze e differenze, si può anche capire l’identità come un modo di porre ordine nell’insieme: un modo intrinsecamente violento, che taglia alla radice l’intrico; un modo possibile, forse comune e ricorrente nel nostro mondo, non però l’unico modo, bensì un modo tra le diverse possibilità di districarsi in mezzo alle somiglianze e alle differenze.
Il sesto capitolo non ha l’intento di illustrare pregi o qualità di questo approccio alternativo: è già stato scritto un libro su questo argomento, esplicitamente dedicato alle Somiglianze. Obiettivo del capitolo è invece quello di fare vedere come a partire dalle rappresentazioni e dalle analisi critiche dell’identità si possa uscire dal suo perimetro e approdare al terreno delle somiglianze. Il capitolo parte dall’insegnamento di due maestri dell’antropologia: Alfred R. Radcliffe-Brown, che con il suo rigore concettuale si era ben guardato dal lasciarsi sedurre dalla corrente identitaria che cominciava a prendere forma nell’antropologia sociale, e Claude Lévi-Strauss, che ormai lambito dalla corrente identitaria in antropologia invita tuttavia a considerare l’identità come una credenza particolare, ovvero come il prodotto di una specifica tradizione di pensiero.
Se si segue lo spunto di Lévi-Strauss e si intende approfondire il suo suggerimento, non si può fare a meno di risalire addirittura a Parmenide, il filosofo della Magna Grecia a cui si deve la definizione più chiara e incontrovertibile di identità. Con una precisazione però estremamente importante: per Parmenide l’identità è attribuibile soltanto al mondo divino dell’Essere; l’identità è inapplicabile (e in effetti è irreperibile) nel mondo delle cose naturali e umane, il mondo della molteplicità, del divenire, del non-essere. Pur senza evocare Parmenide, Vincent Descombes, attento anche lui (come tutti gli autori di questo volume) a Les embarras de l’identité, inizia il secondo capitolo del suo libro esattamente con questa domanda molto parmenidea: “Il concetto di identità è applicabile in questo mondo?”.
Vi è da supporre che gli antropologi – quasi tutti interessati esclusivamente ai problemi della società contemporanea – reagiscano con un’alzata di spalle a questo tentativo di rievocare un filosofo tanto antico, così lontano da noi sotto il profilo cronologico e culturale. Che cosa c’entra Parmenide con i nostri dibattiti sull’identità? Proprio questo è il motivo per cui nel sesto capitolo diverse pagine sono state dedicate a questo così poco attuale filosofo della Magna Grecia: fare vedere che qualche connessione c’è; fare vedere – per cominciare – come la scoperta, o l’invenzione, dell’identità da parte di questo poeta-filosofo sia avvenuta in un contesto tutto intriso di mitologia e di teologia. Non interessa agli antropologi sapere come è nato il pensiero dell’identità, quel pensiero che ha poi percorso, come un filo ininterrotto, l’intera storia del pensiero occidentale? Non interessa agli antropologi capire come sia stato possibile che dalle vette sublimi dell’Essere, indagate dall’ontologia e dalla metafisica, l’identità sia poi penetrata nel mondo delle società e dei gruppi umani, delle mentalità e dei comportamenti della vita di tutti i giorni?
Nel sesto capitolo si richiama l’attenzione su un processo a cui l’idea di identità era già stata sottoposta nella filosofia greca a opera di Platone e di Aristotele: il processo di distribuzione; l’identità viene infatti distribuita prima tra le idee (Platone) e poi tra le sostanze metafisiche (Aristotele). È interessante capire come l’identità subisca storicamente questo processo distributivo: se a lungo tale processo era stato tenuto sotto controllo dal pensiero filosofico con i principi rigidi della metafisica, nella seconda metà del Novecento osserviamo una distribuzione per così dire sempre più “democratica”, a favore della gente comune, una distribuzione nel contempo sempre più dettagliata, frammentata – a opera questa volta non della filosofia, ma delle scienze umane e sociali – fino ad arrivare allo sciame di identità, che è sotto gli occhi di tutti e di cui non sarebbe male che anche gli antropologi cominciassero a interessarsi come fenomeno che contraddistingue buona parte della cultura contemporanea.
È importante rendersi conto di che cosa succede all’identità quando essa viene distribuita: perde via via quegli attributi che, all’origine, ne facevano una sfera unica, compatta, completa, perfetta (la sfera dell’Essere di Parmenide). Un’identità distribuita non può più essere un’identità perfetta: e quanto più è distribuita – passando dall’Uno ai molti (molte idee, molte sostanze, molte società, molte persone e così via) – tanto più diviene imperfetta. Nel sesto capitolo si accenna a Thomas Reid, filosofo scozzese del Settecento che, sulla scia di Hume, vedeva il mondo tutto costellato di identità imperfette: per esempio, non è forse un’identità inevitabilmente imperfetta il rapporto tra una piccola, giovane quercia e quella “stessa” quercia ormai divenuta grande, o tra Thomas bambino di cinque anni e la “medesima” persona a quarant’anni? Nella distribuzione mondana delle identità, noi “attribuiamo identità” – come diceva Reid – a quell’albero e a quella persona: diciamo infatti che sono lo “stesso” albero, la “medesima” persona, anche se l’albero e la persona che vediamo oggi non sono esattamente quelli di dieci anni fa e nemmeno di ieri. Ciò che attribuiamo alle cose del mondo sono soltanto “identità imperfette” (e quanto più sono imperfette, tanto più possono essere distribuite: la strepitosa proliferazione delle identità, a cui assistiamo nella società contemporanea, è senz’altro frutto della loro imperfezione e viceversa).
L’accenno a Reid non ha un significato meramente erudito: se da un lato Reid aiuta a vedere come la distribuzione nel mondo del concetto di identità dia luogo a una molteplicità di identità imperfette, dall’altro consente di compiere un passo ulteriore e decisivo, cioè renderci conto che le identità imperfette non sono altro che somiglianze. È soltanto per una convenzione, per una “comodità di linguaggio”, che noi diciamo esservi identità tra una persona a vent’anni e questa “stessa” persona a cinquanta: in realtà si tratta di un rapporto di somiglianze e differenze.
Il sesto capitolo insiste sull’importanza decisiva di questo passaggio dall’identità alle somiglianze, ovvero sull’inevitabilità dell’approdo alle somiglianze, come appare in maniera emblematica nel caso di Émile Meyerson. Il fondatore dell’epistemologia francese, riconoscendosi del tutto nel pensiero occidentale, si presenta come un convinto sostenitore dell’identità: egli si riferisce esplicitamente alla sfera di Parmenide e colloca il principio di identità alla base di tutto il pensiero scientifico. Una volta calata nel mondo e distribuita tra i fenomeni, l’identità viene però inesorabilmente sostituita dalle somiglianze: “sempre” – afferma Meyerson – “anche quando noi affermiamo di trattare di identici, non trattiamo che di simili”. Quindi – come già per Reid – l’identità “distribuita” tra i fenomeni del mondo è un’identità che viene non già scoperta o osservata in re, bensì “attribuita” alle cose, così da nascondere le loro somiglianze. Non solo, ma Meyerson giunge fino al punto di farci cogliere con precisione il modo con cui trasformiamo le somiglianze in identità, ovvero il modo con cui attribuiamo identità là dove invece ci sono somiglianze: “noi rendiamo i simili identici, scartando momentaneamente ciò che li diversifica”, cioè eliminando le loro differenze. Quale sia poi il grado di illusorietà o di consapevolezza, il carattere di espediente momentaneo o invece duraturo, sufficientemente motivato o immotivato, di queste operazioni è tutto da verificare, osservando di volta in volta i diversi contesti e le diverse modalità con cui si interviene nell’intrico delle somiglianze e differenze.
Infine, la tesi secondo cui, anche quando “si dice identità” (si afferma, si attribuisce, si difende una qualche identità), non si tratta d’altro che di “manipolazione di somiglianze e differenze”, intende avere un duplice significato. In primo luogo, quella tesi è un avvertimento: ci segnala il pericolo di cadere in ciò che giustamente è stata chiamata la “trappola” dell’identità, che per noi consiste nel considerare identità ciò che invece non sono altro che somiglianze e differenze.
In secondo luogo, questa stessa tesi pone in luce un carattere estremamente importante delle somiglianze: la loro resilienza. Può succedere – ed è quello che constatiamo tutti i giorni – che la trama delle somiglianze e delle differenze venga quasi del tutto coperta e tenuta nascosta dal discorso ininterrotto delle identità. Le somiglianze quasi non si vedono. Eppure – come affermava Michel Foucault – per quanto emarginate, schiacciate dalle identità, le somiglianze continuano a emettere il loro “mormorio” incessante.
(…)
Come si è detto, questo volume è dedicato a Ugo Fabietti. Riconsiderando i suoi contributi, a cominciare dal saggio sulle “identità collettive” che abbiamo voluto porre come primo capitolo, la figura di Fabietti ci appare come quella di uno strenuo difensore del concetto di identità: dell’identità – egli afferma – non possono fare a meno gli esseri umani sia come persone singole sia come gruppi sociali, e all’identità, di conseguenza, debbono fare ricorso gli antropologi. All’interno del nostro gruppo di ricerca, Fabietti è colui che in maniera più convinta e programmatica ha voluto “lavorare dentro l’identità”. Eppure, proprio nel saggio di Fabietti sulle “identità collettive” vediamo le somiglianze bussare insistentemente all’attenzione dell’antropologo sotto forma del comportamento mimetico: significativamente, il saggio inizia e si conclude su questo tema.
All’autore dell’ultimo capitolo sarebbe piaciuto riprendere il dialogo con Fabietti e con tutti gli altri componenti del gruppo esattamente da qui: stabilendo un accordo e ponendo una domanda.
L’accordo, facilmente acquisibile (si suppone), riguarda l’importanza fondamentale della mimesi nel comportamento umano, e Fabietti ce lo ricorda con la sua insistenza su questo tema.
La domanda sarebbe invece formulabile in questo modo: la mimesi ha a che fare con l’identità? Si inquadra senza problemi in una prospettiva identitaria? Oppure, per essere compresa appieno nelle sue motivazioni di fondo, nei suoi meccanismi, nelle sue implicazioni, nei suoi risultati non richiede invece di uscire decisamente dall’identità e nel frattempo, o immediatamente dopo, elaborare un’adeguata e approfondita teoria delle somiglianze e delle differenze?
Francesco Remotti
L’estratto è pubblicato in accordo con la casa editrice e ed reperibile in Francesco Remotti, a cura di, Sull’Identità, Raffaello Cortina Editore, 2021 (link al libro qui)
Immagine: René Magritte, Le double secret – Der geheime Doppelgänger – The double secret
Centre Pompidou, Paris